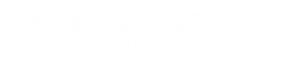Perché studio Economia? La domanda cruciale che ha dato il titolo alla manifestazione organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (Dises) il 7 giugno nell’Aula Azzurra di Monte Sant’Angelo in occasione della settimana di celebrazioni per i 792 anni dell’Università Federico II. “Un’iniziativa che sta diventando una tradizione, il compleanno dell’Ateneo che ogni struttura didattica festeggia declinandolo alla propria maniera. Una manifestazione aperta al pubblico, nel corso della quale divulghiamo il nostro lavoro e le sue ricadute”, commenta la prof.ssa Maria Gabriella Graziano che ha presieduto la giornata nel corso della quale sono stati premiati i migliori studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea incardinati presso il Dipartimento e le studentesse
vincitrici del Premio Lilli Basile. “È un’occasione di incontro per riconoscere il merito in primo luogo dei ragazzi, veri protagonisti, ma anche dei docenti. Infatti, cerchiamo di dare spazio a ricercatori che abbiano ricevuto delle promozioni a cui affidiamo il compito di rendere accessibili delle applicazioni della ricerca talvolta non immediatamente percepibili”, sottolinea il prof. Tullio Jappelli, Direttore del Dipartimento. E gli studi economici risultano essere estremamente pervasivi e aperti al confronto continuo con altri saperi, per esempio con il Diritto, come ha mostrato nella presentazione il prof. Giovanni Immordino, docente di Economia Politica, che ha analizzato, con la platea, l’efficacia della legge sui pentiti di Mafia. Come si fa a valutarne i risultati? Rispondendo a due domande. A partire dalla sua introduzione, sono diminuiti i crimini? E i processi sono aumentati? Ma le domande presentano un’ambiguità intrinseca: se la procedura introdotta permette di scoprire più crimini, allora funziona, ma si può dire che si commettono meno reati quando se ne registrano di più? Pertanto si adopera come parametro di riferimento il numero degli omicidi il cui dato è, in genere, allineato all’evento effettivo. Se una persona viene uccisa, infatti, si viene a sapere. “Abbiamo assunto i dati relativi alle quattro principali organizzazioni criminali di riferimento, dal 1983 al 2010. Evidenziando gli omicidi di Mafia rispetto a quelli volontari per vedere
se vi è stata, o meno, una diminuzione – spiega il docente – Dopo la crescita degli anni ’80, l’andamento mostra effettivamente una riduzione degli assassinii mafiosi rispetto a quelli volontari, più o meno sempre gli stessi, con andamenti simili, in province diverse e con riferimento ad organizzazioni diverse”. Il picco di minore discrepanza si registra nel 1988, anno a partire dal quale si evidenziano le differenze fra i due eventi in particolare dall’introduzione, da parte del Legislatore, delle norme che distinguono l’associazione a delinquere semplice da quella di stampo mafioso prevedendo, nel secondo caso, pene più lievi per chi rende testimonianza. “Dire se queste ricadute siano sufficienti a giudicare gli effetti della norma non è, però, compito dell’economista”. Altri esempi di contaminazione con Sociologia, Medicina, Economia e Biologia li fornisce il prof. Massimo Aria, docente di Statistica Sociale, con tre esempi: la Google Car pilotata da un software che ricorre alla Statistica per prevenire gli incidenti; gli algoritmi di simulazione nei video giochi; la gestione, completamente automatizzata del magazzino Amazon per prevedere le richieste di prodotto. “Un bambino impara dall’esperienza e fa delle valutazioni prima di agire, forse si tratta di una dote innata. La Statistica nasce come disciplina dei numeri in ere remotissime. Il primo manuale per censimenti risale all’epoca sumera e i Romani facevano il censimento della popolazione ogni cinque anni, più frequentemente di noi. Il nome deriva proprio dalla parola Stato”. Con la Rivoluzione Scientifica diventa uno strumento per analizzare piccoli campioni casuali. “La prima attività della nostra società è la produzione di dati, ma le informazioni si estraggono anche da testi, contatti in rete, condivisioni, acquisti”, dice il docente raccontando il suo primo lavoro (“Un progetto di gestione del traffico all’ingresso di un piccolo centro, dal quale si accedeva ad alta velocità da una superstrada, causando molti incidenti. Abbiamo fatto centinaia di prove, studiando movimenti e perfino respiri degli automobilisti per capire come indurli a rallentare senza compiere azioni impulsive”). In un progetto più recente ha collaborato con i biologi dell’Ateneo per verificare le teorie sull’apprendimento sociale dei cani, lavorando con cinquanta fra Labrador e Terranova della Scuola di salvataggio in acqua, divisi in due gruppi per imparare degli esercizi mai visti in precedenza, uno attraverso l’osservazione di altri cani, l’altro senza alcun ‘social learning’. Il 62% degli esemplari del primo gruppo e solo il 23% del secondo hanno superato l’esame, verificando le teorie sull’apprendimento di cani che lavorano per il salvataggio in mare, in montagna, durante i terremoti. Un lavoro del quale hanno parlato tutte le principali riviste scientifiche di settore. “I giornali prevedono che la Data Science sarà la disciplina più sexy del futuro”, scherza in conclusione il docente.
Simona Pasquale
vincitrici del Premio Lilli Basile. “È un’occasione di incontro per riconoscere il merito in primo luogo dei ragazzi, veri protagonisti, ma anche dei docenti. Infatti, cerchiamo di dare spazio a ricercatori che abbiano ricevuto delle promozioni a cui affidiamo il compito di rendere accessibili delle applicazioni della ricerca talvolta non immediatamente percepibili”, sottolinea il prof. Tullio Jappelli, Direttore del Dipartimento. E gli studi economici risultano essere estremamente pervasivi e aperti al confronto continuo con altri saperi, per esempio con il Diritto, come ha mostrato nella presentazione il prof. Giovanni Immordino, docente di Economia Politica, che ha analizzato, con la platea, l’efficacia della legge sui pentiti di Mafia. Come si fa a valutarne i risultati? Rispondendo a due domande. A partire dalla sua introduzione, sono diminuiti i crimini? E i processi sono aumentati? Ma le domande presentano un’ambiguità intrinseca: se la procedura introdotta permette di scoprire più crimini, allora funziona, ma si può dire che si commettono meno reati quando se ne registrano di più? Pertanto si adopera come parametro di riferimento il numero degli omicidi il cui dato è, in genere, allineato all’evento effettivo. Se una persona viene uccisa, infatti, si viene a sapere. “Abbiamo assunto i dati relativi alle quattro principali organizzazioni criminali di riferimento, dal 1983 al 2010. Evidenziando gli omicidi di Mafia rispetto a quelli volontari per vedere
se vi è stata, o meno, una diminuzione – spiega il docente – Dopo la crescita degli anni ’80, l’andamento mostra effettivamente una riduzione degli assassinii mafiosi rispetto a quelli volontari, più o meno sempre gli stessi, con andamenti simili, in province diverse e con riferimento ad organizzazioni diverse”. Il picco di minore discrepanza si registra nel 1988, anno a partire dal quale si evidenziano le differenze fra i due eventi in particolare dall’introduzione, da parte del Legislatore, delle norme che distinguono l’associazione a delinquere semplice da quella di stampo mafioso prevedendo, nel secondo caso, pene più lievi per chi rende testimonianza. “Dire se queste ricadute siano sufficienti a giudicare gli effetti della norma non è, però, compito dell’economista”. Altri esempi di contaminazione con Sociologia, Medicina, Economia e Biologia li fornisce il prof. Massimo Aria, docente di Statistica Sociale, con tre esempi: la Google Car pilotata da un software che ricorre alla Statistica per prevenire gli incidenti; gli algoritmi di simulazione nei video giochi; la gestione, completamente automatizzata del magazzino Amazon per prevedere le richieste di prodotto. “Un bambino impara dall’esperienza e fa delle valutazioni prima di agire, forse si tratta di una dote innata. La Statistica nasce come disciplina dei numeri in ere remotissime. Il primo manuale per censimenti risale all’epoca sumera e i Romani facevano il censimento della popolazione ogni cinque anni, più frequentemente di noi. Il nome deriva proprio dalla parola Stato”. Con la Rivoluzione Scientifica diventa uno strumento per analizzare piccoli campioni casuali. “La prima attività della nostra società è la produzione di dati, ma le informazioni si estraggono anche da testi, contatti in rete, condivisioni, acquisti”, dice il docente raccontando il suo primo lavoro (“Un progetto di gestione del traffico all’ingresso di un piccolo centro, dal quale si accedeva ad alta velocità da una superstrada, causando molti incidenti. Abbiamo fatto centinaia di prove, studiando movimenti e perfino respiri degli automobilisti per capire come indurli a rallentare senza compiere azioni impulsive”). In un progetto più recente ha collaborato con i biologi dell’Ateneo per verificare le teorie sull’apprendimento sociale dei cani, lavorando con cinquanta fra Labrador e Terranova della Scuola di salvataggio in acqua, divisi in due gruppi per imparare degli esercizi mai visti in precedenza, uno attraverso l’osservazione di altri cani, l’altro senza alcun ‘social learning’. Il 62% degli esemplari del primo gruppo e solo il 23% del secondo hanno superato l’esame, verificando le teorie sull’apprendimento di cani che lavorano per il salvataggio in mare, in montagna, durante i terremoti. Un lavoro del quale hanno parlato tutte le principali riviste scientifiche di settore. “I giornali prevedono che la Data Science sarà la disciplina più sexy del futuro”, scherza in conclusione il docente.
Simona Pasquale