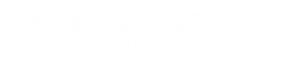A partire dal prossimo semestre, l’esame di Inglese 2 due non dovrebbe più essere l’ostacolo insormontabile che è stato finora per gli studenti di Lingue della triennale. Si apre infatti una nuova fase che rientra in una ristrutturazione complessiva promossa dal Consiglio del Corso di Laurea guidato dalla prof. Silvia Disegni, ma che sarà possibile soprattutto grazie alle modifiche didattiche e organizzative introdotte dalla docente coordinatrice dei corsi di Inglese a Lingue, la prof.ssa Anna La Rana, insieme ai tre lettori e alla prof.ssa Cuccurullo, la nuova docente con contratto a tempo determinato che terrà il corso di Inglese 2 per il prossimo semestre.
Un esame che per molti studenti era diventato un vero incubo: i ragazzi raccontavano di una prova che per il livello di difficoltà segnava uno stacco netto con le precedenti e le successive, e che tra bocciature molto frequenti, lacrime versate, e raccomandazioni improbabili cercate per superarlo, portava diversi studenti anche alla decisione di cambiare lingua.
Un esame che per molti studenti era diventato un vero incubo: i ragazzi raccontavano di una prova che per il livello di difficoltà segnava uno stacco netto con le precedenti e le successive, e che tra bocciature molto frequenti, lacrime versate, e raccomandazioni improbabili cercate per superarlo, portava diversi studenti anche alla decisione di cambiare lingua.
6 esami della lingua
principale in un
triennio: “una follia”
principale in un
triennio: “una follia”
Secondo la prof.ssa Gabriella Mazzon, titolare per cinque anni della cattedra per l’insegnamento di Inglese 2 e 4 come professore associato, e che dallo scorso semestre è diventata invece ordinario all’Università di Cagliari, la spiegazione delle difficoltà percepite dagli studenti è da ricercare fondamentalmente nell’impostazione dei corsi di lingua inglese adottata dall’Ateneo. La strutturazione dei corsi di Inglese adottata finora alla Federico II è stata in effetti piuttosto particolare rispetto ad altri atenei o ad altri corsi di lingua nella stessa università: la previsione di due corsi semestrali ogni anno, invece che un solo corso annuale, fa sì che nel corso della laurea triennale lo studente si trova a dover sostenere 6 esami della lingua principale in un triennio. “Una follia”, commenta la Mazzon. Data questa struttura, spiega la professoressa, gli esami dispari, cioè quelli che capitano dopo il primo semestre di ogni anno – Inglese 1, Inglese 3 e 5 – hanno una funzione di verifica parziale, come di prova appunto di metà anno, mentre sta agli esami dei secondi semestri – Inglese 2 e 4, di cui la docente era titolare – valutare la preparazione complessiva annuale e stabilire se gli studenti siano in grado o meno di passare ai corsi dell’anno successivo. Inoltre, continua la Mazzon, spicca in particolare la differenza tra l’esame di Inglese 1 e 2 anche perché il primo modulo è incentrato in maniera particolare sulla fonetica e sul riconoscimento dei vocaboli, e si conclude con un esame che è solo scritto; mentre nel secondo, nel corso del quale si richiede agli studenti di cominciare anche a produrre, non solo a riconoscere il linguaggio, è prevista invece una prova finale sia scritta che orale. Argomenti e modalità diverse su cui sono improntati i corsi del primo e del secondo semestre, e che vale sia per il primo che per il secondo anno (Inglese 3 è prevalentemente di lettura, il 4 di scrittura): questi i motivi che secondo la docente creerebbero un’apparente differenza di livello tra le due prove, che rende in effetti “molto basso” il tasso di studenti che hanno superato il suo esame, ammette la stessa Mazzon, evidenziando anche che in genere chi non superava l’esame al primo o secondo tentativo poteva anche ripeterlo molte volte senza presentare alcun miglioramento da un appello all’altro; una precisa “costanza di risultati attraverso le diverse sezioni”. Questo anche perché con questo tipo di sistema di moduli le lacune “tendono a rimanere stratificate”, emergendo anche agli esami successivi; dipende quindi molto anche dalle basi con cui si arriva.
Un’impostazione nella quale, soprattutto, “abbiamo trascorso più ore a fare esami che a fare lezioni”, sostiene la Mazzon; per ogni ciclo semestrale infatti la didattica è limitata a 3 ore di lettorato a settimana – “inutili perché c’è un solo lettore per classe, che al primo anno può essere anche di più di 200 persone”- , lettori che, sottolinea la docente, offrono su base volontaria anche ore di ricevimento e assistenza agli studenti in laboratorio – laboratori che hanno certo una capienza di soli 30 posti, ma secondo la Mazzon in genere “di studenti ne arrivano in tre”. Questo per quanto riguarda i lettori ma ai docenti toccano solo 12 ore complessive a semestre: una a settimana, il che riduce il contatto con gli studenti ad un tempo davvero limitato. “Ci si rende sicuramente conto che l’offerta è limitata, ma non possiamo però abbassare il livello, è un’istituzione universitaria” afferma la Mazzon, aggiungendo che “evidentemente gli studenti avrebbero dovuto fare a casa un lavoro più intenso”. L’unico rimpianto della Mazzon nel trasferimento è per i ragazzi della Specialistica, con cui si riesce a lavorare meglio perché sono meno e hanno già superato questa “selezione”; d’altra parte questo tipo di impostazione dei corsi conferma il fatto che in quest’ateneo “rimane privilegiato lo studio letterario a quello linguistico”, conclude la professoressa.
All’organizzazione modulare, al numero ridotto di ore di lezione, alla carenza dei lettori, però, probabilmente, aggiunta una componente determinata dall’interpretazione personale che la docente ha dato al suo corso, che ha fatto percepire agli studenti l’esame come nettamente più difficile rispetto alla media.
Un’impostazione nella quale, soprattutto, “abbiamo trascorso più ore a fare esami che a fare lezioni”, sostiene la Mazzon; per ogni ciclo semestrale infatti la didattica è limitata a 3 ore di lettorato a settimana – “inutili perché c’è un solo lettore per classe, che al primo anno può essere anche di più di 200 persone”- , lettori che, sottolinea la docente, offrono su base volontaria anche ore di ricevimento e assistenza agli studenti in laboratorio – laboratori che hanno certo una capienza di soli 30 posti, ma secondo la Mazzon in genere “di studenti ne arrivano in tre”. Questo per quanto riguarda i lettori ma ai docenti toccano solo 12 ore complessive a semestre: una a settimana, il che riduce il contatto con gli studenti ad un tempo davvero limitato. “Ci si rende sicuramente conto che l’offerta è limitata, ma non possiamo però abbassare il livello, è un’istituzione universitaria” afferma la Mazzon, aggiungendo che “evidentemente gli studenti avrebbero dovuto fare a casa un lavoro più intenso”. L’unico rimpianto della Mazzon nel trasferimento è per i ragazzi della Specialistica, con cui si riesce a lavorare meglio perché sono meno e hanno già superato questa “selezione”; d’altra parte questo tipo di impostazione dei corsi conferma il fatto che in quest’ateneo “rimane privilegiato lo studio letterario a quello linguistico”, conclude la professoressa.
All’organizzazione modulare, al numero ridotto di ore di lezione, alla carenza dei lettori, però, probabilmente, aggiunta una componente determinata dall’interpretazione personale che la docente ha dato al suo corso, che ha fatto percepire agli studenti l’esame come nettamente più difficile rispetto alla media.
Il futuro: un solo
esame annuale
da 8 o 9 crediti
esame annuale
da 8 o 9 crediti
La modifica approvata dal Consiglio del Corso di Laurea invece, e che aspetta solo di entrare in vigore, forse già dal prossimo anno accademico, prevederà un solo esame annuale da 8 o 9 crediti, spiega la prof.ssa La Rana, come accade nella maggior pare degli altri corsi di lingue. Il problema, come sempre, è trovare le risorse adeguate che consentano di mettere poi realmente in opera le modifiche introdotte, compito per il quale si adopera in maniera particolare la professoressa Disegni, come Presidente del Corso di Laurea, andando a bussare pare ormai quasi ogni giorno alle porte del Presidente del Polo, del Preside della Facoltà, del Direttore del Dipartimento. “Ci stiamo arrivando – sostiene la prof.ssa La Rana- ma con molta fatica”. Sicuramente è riuscito ai docenti di tamponare lo svuotamento creatosi improvvisamente all’interno del Corso di Laurea dopo il trasferimento della prof. Mazzon e il pensionamento di uno dei lettori che adesso si ritrovano in tre: due persone in meno che possono pesare parecchio se tutti i corsi di inglese a Lingue si reggono su un solo professore associato, ovvero La Rana, e tre lettori. Gli strumenti prioritari quindi, spiega La Rana, sono aule in più e, ovviamente, un aumento del personale. Il contratto temporaneo con la prof.ssa Cuccurullo permetterà di svolgere regolarmente i corsi per questo semestre, ma alla scadenza del suo contratto dovrebbe entrare stabilmente in organico un ricercatore, oltre ad un nuovo lettore che andrà a sostituire quello da poco andato in pensione. Strumenti che rappresentano davvero il minimo indispensabile in un contesto nel quale un’unica docente si ritrova a dover portare avanti dieci moduli diversi e i lettori mettono a disposizione un surplus di tempo notevole tra laboratorio linguistico, ricevimento, esami. “Cerchiamo di offrire attività esterne aggiuntive, tutto quello che si riesce, data l’offerta didattica limitata”, continua la prof. La Rana. Una disponibilità che sicuramente gli studenti riconoscono e apprezzano, “ma non basta: ci vuole una qualità garantita, non un successo che dipenda da ‘ragioni affettive’”, altrimenti al primo intoppo rischia di crollare una struttura che si regge su basi così fragili e del tutto volontarie.
In ogni caso, a livello didattico anche la prof. La Rana riconosce l’importanza di promuovere una maggiore integrazione tra i moduli dispari e i moduli pari, sebbene, sottolinea, ogni modulo presenti le sue proprie difficoltà: Inglese 1 ad esempio è basato prevalentemente sul riconoscimento fonetico del linguaggio, ma presenta delle prove di ascolto e di dettato che fanno cadere circa il 70% degli studenti, perché sono modalità alle quali non sono abituati e che richiedono anche un impegno attivo nel riconoscimento della funzione comunicativa dei vocaboli.
Per evitare che i ragazzi cadano agli esami del 2°, 3°, o 4° , una svolta reale sarebbe rappresentata dalla possibilità di poter effettuare un “placement test”, un test di livello all’inizio del primo anno, afferma la prof. la Rana, per disporre di un’esatta percezione della preparazione precedente, e per evitare che ogni studente si trascini dietro le proprie lacune. Dopo il test, l’ideale sarebbe far partire dei corsi integrativi per chi ne ha bisogno, in modo tale da intervenire immediatamente sulle lacune più gravi. Un’altra ipotesi nel momento in cui i corsi e gli esami diventeranno annuali: una prova intermedia a gennaio-febbraio che consenta di tastare il polso della situazione e un corso intensivo di recupero di due-tre settimane prima della ripresa dei corsi. Ipotesi che rappresenterebbe anche un impiego più utile del tempo prezioso di docenti e lettori, che attualmente, conferma anche La Rana, viene perso per lo più nella preparazione e nello svolgimento di questi continui esami che i ragazzi devono sostenere nel corso della triennale.
La nuova formula però attende l’approvazione del Consiglio di Facoltà e soprattutto un sostegno in termini di aule e personale.
Diventa difficile altrimenti rincorrere l’obiettivo di allineare i corsi di Lingue della Federico II agli standard europei (“il livello linguistico in uscita dal triennio dovrebbe essere un C1 o poco meno – sostiene la docente- da completare con la specialistica arrivando ad un C2”, ovvero un livello da quasi-madrelingua) piuttosto che limitarsi a produrre poche eccellenze – studenti che hanno percorso brillanti carriere e che spesso tornano a trovare i loro professori, racconta La Rana – che restano però perle rare in una media la cui preparazione rischia di rimanere piuttosto incerta.
Viola Sarnelli
In ogni caso, a livello didattico anche la prof. La Rana riconosce l’importanza di promuovere una maggiore integrazione tra i moduli dispari e i moduli pari, sebbene, sottolinea, ogni modulo presenti le sue proprie difficoltà: Inglese 1 ad esempio è basato prevalentemente sul riconoscimento fonetico del linguaggio, ma presenta delle prove di ascolto e di dettato che fanno cadere circa il 70% degli studenti, perché sono modalità alle quali non sono abituati e che richiedono anche un impegno attivo nel riconoscimento della funzione comunicativa dei vocaboli.
Per evitare che i ragazzi cadano agli esami del 2°, 3°, o 4° , una svolta reale sarebbe rappresentata dalla possibilità di poter effettuare un “placement test”, un test di livello all’inizio del primo anno, afferma la prof. la Rana, per disporre di un’esatta percezione della preparazione precedente, e per evitare che ogni studente si trascini dietro le proprie lacune. Dopo il test, l’ideale sarebbe far partire dei corsi integrativi per chi ne ha bisogno, in modo tale da intervenire immediatamente sulle lacune più gravi. Un’altra ipotesi nel momento in cui i corsi e gli esami diventeranno annuali: una prova intermedia a gennaio-febbraio che consenta di tastare il polso della situazione e un corso intensivo di recupero di due-tre settimane prima della ripresa dei corsi. Ipotesi che rappresenterebbe anche un impiego più utile del tempo prezioso di docenti e lettori, che attualmente, conferma anche La Rana, viene perso per lo più nella preparazione e nello svolgimento di questi continui esami che i ragazzi devono sostenere nel corso della triennale.
La nuova formula però attende l’approvazione del Consiglio di Facoltà e soprattutto un sostegno in termini di aule e personale.
Diventa difficile altrimenti rincorrere l’obiettivo di allineare i corsi di Lingue della Federico II agli standard europei (“il livello linguistico in uscita dal triennio dovrebbe essere un C1 o poco meno – sostiene la docente- da completare con la specialistica arrivando ad un C2”, ovvero un livello da quasi-madrelingua) piuttosto che limitarsi a produrre poche eccellenze – studenti che hanno percorso brillanti carriere e che spesso tornano a trovare i loro professori, racconta La Rana – che restano però perle rare in una media la cui preparazione rischia di rimanere piuttosto incerta.
Viola Sarnelli