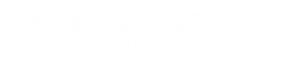In una fase di radicale rinnovamento e transizione che riguarda Studi Umanistici, per alcuni docenti che hanno fatto la storia di questo Dipartimento è arrivato il momento di abbandonare la cattedra in vista della pensione. “Anche se la mente di un professore – argomenta la prof.ssa Adriana Mauriello, 46 anni di insegnamento della Letteratura Italiana in curriculum – non è mai davvero a riposo, perché continua comunque a studiare, scrivere, pubblicare lavori scientifici e partecipare ai convegni. Infatti, è passato meno di un mese e non me ne sono ancora accorta, ma sono sicura che pian piano il vuoto comincerà a farsi sentire”. Nel mese di maggio si è tenuta l’ultima lezione della docente. “In quell’occasione molti colleghi – il Direttore di Dipartimento, prof. Edoardo Massimilla, e il Prorettore, prof. Arturo De Vivo – hanno voluto festeggiarmi e con mia grande sorpresa sono venuti ad assistere. È un ricordo che porterò sempre nel cuore”. Dal mese di novembre la docente, infatti, passa il testimone del coordinamento del Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne al prof. Francesco Montuori, docente di Storia della Lingua Italiana. Un ruolo importantissimo quest’ultimo, “perché Lettere è il Corso più numeroso a livello dipartimentale e negli ultimi anni è stato protagonista di un boom di immatricolazioni”. Pertanto, la sua organizzazione didattica e scientifica comporta intrinsecamente la risoluzione di tante problematiche e richiede notevole impegno, anche su più livelli. “Non è semplice conciliare tutto, perché – per creare un sistema universitario coerente ed equilibrato – occorre mettere d’accordo le esigenze dei docenti nell’interesse degli studenti insieme alle possibilità tecnico-logistiche a nostra disposizione”.
Il piacere di fare
lezione
lezione
In questi anni, la docente ha rivestito diversi incarichi istituzionali: Coordinatrice di Lettere, ma anche responsabile delle sedute di laurea e degli orari per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna. “Ma ciò per cui proverò più nostalgia sarà il rapporto con gli studenti e i colleghi, il cui affetto – che ricevo tutt’oggi – è segno del fatto che probabilmente ho lavorato bene. Ovviamente, nei limiti delle mie facoltà. Credo di non avere mai evitato di rispondere alle mail di uno studente o saltato, senza giusta motivazione, il ricevimento”. I ricordi più belli della sua carriera affondano proprio nel quotidiano, “nel piacere di fare lezione – anche in maniera creativa – perché solo in aula le competenze che uno ha acquisito si mettono davvero in gioco. Io ho la fama di essere rigida agli esami, lo so, ma vorrei dire che tutto è stato fatto per la crescita degli studenti. Contribuire alla formazione è la mia soddisfazione più grande”. Il suo percorso d’insegnamento è costellato da alcune ripetute costanti, in primis il bisogno di un aggiornamento continuo. “Il nostro è un lavoro particolare nel senso che non si chiude davvero con la pensione. Ho tenuto la mia prima lezione il 1° gennaio 1972. Da allora è cambiato tutto, tranne l’amore per la letteratura, che ho cercato di trasmettere agli studenti – così come con me hanno fatto i miei Maestri, tra cui non posso fare a meno di citare Giancarlo Mazzacurati, di cui sono stati allievi tanti docenti che insegnano presso il Dipartimento, i professori Francesco Paolo Botti, Ettore Massarese, Matteo Palumbo, Antonio Saccone – con un’appropriata metodologia di studio”, quasi un rituale in cui il primo step è ineludibilmente rappresentato dalla lettura del testo, a partire “dalla sua schedatura e analisi critica. Bisogna fare amicizia con gli esiti della scrittura. A lezione non ho mai seguito pedissequamente il manuale, perché si presuppone che all’Università gli studenti siano in grado di leggerlo e comprenderlo da soli. Piuttosto, m’interessa inquadrare il testo all’interno della temperie culturale in cui è nato e contestualizzarlo nelle sue coordinate storico-geografiche, affinché il discente possa avere una visione a 360 gradi di ciò che legge”. Indispensabile, dunque, la frequenza in questo percorso di arricchimento e scambio reciproco tra la figura del professore e quella dell’allievo. “Allo studente giova moltissimo ascoltare dal vivo il docente e allo stesso tempo il docente necessita del feedback dei propri uditori per capire in che modo impostare il proprio lavoro. Non c’è cosa più gratificante che fornire un buon servizio, cioè soddisfare una richiesta di spiegazione da parte degli studenti, interagire con loro, chiarire i dubbi e sentirsi dire ‘sì, ho capito’”. Nello studio vale una sola regola: “lasciarsi trasportare dalle proprie passioni. In tutti i campi è difficile trovare sbocchi lavorativi immediati, ma forse Lettere Moderne ne dà meno, perché richiede necessariamente la prosecuzione degli studi nel livello Magistrale. Alcuni purtroppo scelgono Lettere come il male minore, perché in assenza del numero chiuso si percepisce come più accessibile rispetto ad altri ed erroneamente si crede che italiano, latino, storia e geografia siano materie già affrontate a scuola e che, quindi, all’Università non dovrebbero creare troppi problemi”. Ma come la scuola, in effetti, di riflesso anche l’Università è mutata profondamente nei suoi diversi passaggi storici, “dal Vecchio al Nuovo Ordinamento, dalla Facoltà al Dipartimento, dal Dipartimento alla Sezione di Filologia moderna, si è molto burocratizzata e nel tentativo di migliorarsi oggi corre il rischio di imbattersi in vincoli asfittici che tendono a pregiudicare la relazione con lo studente, a discapito di necessità organizzative”. In ogni caso, “non vorrei mai lasciarla, continuo ancora ad andare nel mio studio di martedì, giorno di ricevimento, e so che tra un po’ avverrà questo distacco definitivo, ma lascio in buone mani ciò che ho costruito e spero che la mia esperienza possa essere un viatico per fare ancora meglio”.