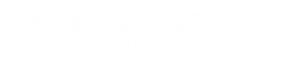Il professor Andrea Mazzucchi, ordinario di Filologia della letteratura italiana, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, ha annunciato la sua candidatura a Rettore dell’Ateneo federiciano attraverso una lettera indirizzata ai docenti, agli studenti ed al personale tecnico-amministrativo.
Care Colleghe e Cari Colleghi,
Care e Cari Componenti del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario,
Care Studentesse e Cari Studenti,
non senza emozione, ma con il massimo senso di responsabilità desidero comunicarvi la decisione di proporre la mia candidatura alla carica di Rettore della nostra Università.
La Federico II è un patrimonio straordinario, non soltanto per Napoli e per la Campania, ma per l’intero Paese e per la comunità scientifica internazionale. È la più antica università laica del mondo, e opera per offrire a tutti (senza distinzione di ceto o di origine) l’accesso al sapere e alla formazione, cercando di attuare quella “utopia possibile dell’educazione” finalizzata a ridurre, attraverso il sapere condiviso, i divari sociali. Per tale motivo da secoli la Federico II rappresenta un presidio di conoscenza, cultura e progresso civile: un bene comune e un formidabile motore di innovazione radicato nella città e nel Mezzogiorno d’Europa e, insieme, un polo scientifico di respiro globale.
Di fronte all’impellenza delle nuove esigenze sociali e culturali del presente, il nostro Ateneo deve interrogarsi a fondo sul proprio ruolo e su come continuare a svolgerlo al meglio. Per rispondere, serve condividere un’idea comune di Università e una visione complessiva del suo compito nella società. Questa visione per me non può che fondarsi sulla nostra Costituzione: l’università come servizio pubblico che garantisce a tutti il diritto allo studio per il pieno sviluppo della persona. Dante (l’autore a cui ho dedicato larga parte della mia attività di ricerca) diceva che “tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere”: l’Ateneo deve esaltare e proteggere quel desiderio, tutelando autonomia, libertà di insegnamento e ricerca, ma soprattutto promuovendo l’accesso al sapere per tutti.
La radicale trasformazione dei sistemi della ricerca e della didattica, l’impatto delle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, l’esigenza imprescindibile di laboratori e di biblioteche sempre più all’avanguardia ed efficienti, il rafforzamento delle reti internazionali, il dovere di garantire diritto allo studio e inclusione sociale: sono questi alcuni dei terreni sui quali la nostra comunità è chiamata a misurarsi. Sono questioni che non riguardano soltanto l’efficienza del nostro Ateneo, ma il ruolo che la Federico II continuerà a svolgere nello sviluppo della società italiana ed europea, e nella crescita culturale, scientifica ed economica della città di Napoli.
Per affrontarle, credo sia necessario proporre una visione del nostro Ateneo come di una istituzione democratica, aperta, inclusiva, pubblica, attenta alle urgenze del presente, prospettica e predittiva rispetto alle trasformazioni del futuro e soprattutto unita nelle sue complesse articolazioni. Nessun progetto, ancor più se ambizioso, può realizzarsi senza la condivisione, senza il confronto aperto, senza il riconoscimento del valore e delle prerogative di ciascuna delle parti che cooperano in quel complesso organismo che è la Federico II, in cui ogni singola area può rappresentare una preziosa risorsa per le altre e in dialogo con le altre: area umanistica, tecnico-scientifica e sanitaria (quest’ultima chiamata a svolgere anche gravosi compiti assistenziali funzionali alla didattica, alla ricerca scientifica e alla tutela della vita e della salute) non devono concepirsi come mondi paralleli, ma come parti di un unico orizzonte, in cui consiste la forza e la qualità della nostra Università.
L’ateneo che immagino deve essere uno spazio di compartecipazione autentica e non un arcipelago di eccellenze prive di collegamento reciproco, né un’arena improntata unicamente alla competizione (tra singoli studiosi o tra interi dipartimenti): docenti, ricercatori e ricercatrici, personale tecnico- amministrativo e bibliotecario, studenti e studentesse, ognuno con il proprio contributo, sono parte indispensabile di un disegno che deve essere comune. Una visione comune e lungimirante, una gestione rigorosa, ma partecipata, un centro culturale vivo ed in continua evoluzione, capace di dialogare in modo trasparente e regolato con le altre istituzioni e con il mondo produttivo, ma consapevole dell’assoluto rilievo della propria autonomia e responsabilità sociale.
E proprio perché la fase che ci attende non sarà semplice (segnata da prospettive di contrazione del sistema universitario, tra calo demografico e riduzione delle risorse, legate anche alla conclusione del PNRR) sarà indispensabile affrontarla con processi decisionali condivisi e coniugando una visione prospettica di alto profilo intellettuale con un oculato e consapevole governo dei processi e delle risorse che ne derivano. Credo che la nostra università debba essere in grado di amministrare con responsabilità e consapevolezza le possibilità che le vengono fornite. Allo stesso tempo ritengo che sia chiamata a promuovere un dialogo corretto e proficuo con le istituzioni, in primo luogo con gli altri atenei campani, ma anche attraverso gli organi assembleari in cui ha voce (per esempio la CRUI) per rivendicare un ruolo attivo nelle dinamiche di cambiamento.
In questa prospettiva, la nostra comunità è senza dubbio in una condizione privilegiata, perché può far tesoro delle molte e variegate competenze
disciplinari delle colleghe e dei colleghi, che hanno fatto della Federico II un polo di eccellenza nella ricerca e nell’insegnamento riconosciuto a livello mondiale. Da questo prestigio bisogna partire, con l’obiettivo, però, di potenziarlo anche attraverso la capacità di valorizzare la generazione più giovane della nostra comunità. Solo l’intreccio tra il patrimonio consolidato e le nuove intelligenze che lo arricchiscono riuscirà a garantire alla nostra Università la forza di immaginare il proprio futuro con ambizione e determinazione.
Un’università moderna e competitiva deve avere come proprio asse strategico imprescindibile le politiche di genere. Promuovere la parità significa non solo garantire diritti e opportunità uguali a tutte e a tutti, ma anche valorizzare la pluralità di prospettive che arricchisce la ricerca, la didattica e la vita accademica. Un ateneo che investe in equità di genere rafforza la propria reputazione internazionale, accede a reti e finanziamenti europei, e soprattutto crea un ambiente inclusivo, capace di attrarre e trattenere talenti.
L’esperienza accademica maturata nel corso degli anni mi ha insegnato che autorevolezza e credibilità nascono non solo dai risultati conseguiti, ma soprattutto dalla capacità di metterli al servizio della collettività. La scienza è autentica solo quando diventa bene comune, motore di crescita civile e culturale.
A rafforzare questa convinzione hanno contribuito i ruoli scientifici e istituzionali che ho avuto l’onore di ricoprire nel corso degli ultimi anni: ho dedicato la mia vita di studioso a Dante, alla letteratura italiana, ai manoscritti medioevali e alle stampe antiche, alle intersezioni tra i saperi filologici e le nuove tecnologie digitali e dell’automazione; sono stato coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna, mentre oggi coordino il Dottorato di ricerca in “Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi” della Scuola Superiore Meridionale e sono membro del Collegio del Dottorato di ricerca in “Filologia romanza e italiana digitale” della Scuola Normale Superiore di Pisa; sono stato prima vicepresidente e poi presidente della Scuola di Scienze Umane e Sociali; per un biennio, ancora, sono stato rappresentante dei professori ordinari in Senato accademico, nel cui consesso siedo ora come rappresentante dei Direttori di Dipartimento.
Attualmente sono infatti al mio secondo mandato come Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici: una delle strutture più grandi d’Italia, recentemente riconosciuta d’Eccellenza (2023-2027) insieme ad altri 11 dipartimenti del nostro Ateneo. La direzione di un dipartimento così vasto, articolato e complesso mi ha dato l’opportunità non solo di valorizzarne lo straordinario potenziale, ma anche di affrontare, governare e ricomporre con efficacia le inevitabili criticità, sviluppando strategie di coordinamento e di
sintesi che hanno consentito alla struttura di crescere armonicamente e di consolidarsi, sia sul piano scientifico che su quello dell’organizzazione amministrativa e finanziaria.
Faccio parte di diverse istituzioni e accademie culturali nazionali e internazionali, ho fondato e dirigo la Scuola di alta formazione in Storia e filologia del manoscritto e del libro antico che ha sede presso la Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli (e ne ha consentito la riapertura, dopo le tristi vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta) e la Scuola Dantesca Estiva per la formazione degli insegnanti, che è ospitata nella splendida cornice di Villa Ferretti a Bacoli. Coordino a livello nazionale, nell’ambito dei progetti PNRR, lo Spoke 3 (Digital Libraries, Archives and Philology) di CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society), unico Partenariato esteso di area umanistica costituitosi nel 2022 in una Fondazione, nel cui Consiglio di Amministrazione siedo, e che ha tra i suoi principali obiettivi la promozione delle Digital humanities. Ho anche preso parte, in qualità di coordinatore di una commissione di esperti, al confronto sulle politiche della ricerca in Italia e alla stesura del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, pensato per contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, delle priorità della Commissione Europea, degli Obiettivi della politica di coesione 2021-2027 nonché all’iniziativa Next Generation EU.
Attraverso queste esperienze credo anche di aver maturato una capacità gestionale, costruita sia nell’attitudine a dialogare con le persone della più diversa provenienza culturale e delle più varie competenze, sia nel coordinamento di risorse e strategie, orientate a favorire l’innovazione, l’interdisciplinarità e il trasferimento di conoscenze, con l’obiettivo di rendere l’università un attore propositivo rispetto alle sfide future. E dico ciò convinto anche che nessuno da solo può affrontare le sfide che ci attendono. Per questo immagino una struttura di governo fondata sulla ricchezza e varietà dei saperi, sulla corresponsabilità e sulla partecipazione attiva di colleghe e colleghi capaci di mettere a disposizione del nostro Ateneo la propria esperienza, il proprio tessuto di competenze e il proprio impegno. Solo attraverso un’azione corale e sinergica potremo garantire una crescita solida e duratura.
La mia candidatura, maturata anche attraverso il confronto con molti di voi, nasce dalla volontà di pormi al servizio di una comunità, quella della Federico II, cui devo non solo moltissime opportunità, ma che ha anche contribuito a definirmi come ricercatore, come docente e come individuo capace di riconoscere e apprezzare il contributo dell’altro. E nasce da un processo di lunga consuetudine con ogni aspetto della vita d’ateneo, il cui rilancio è possibile solo coniugando la credibilità scientifica che viene dalla ricerca e dalla didattica con le competenze organizzative e gestionali maturate dentro e fuori la Federico II.
L’università è fondata sul legame indissolubile tra ricerca e didattica, che è come dire tra docenti e studenti. Il mio impegno sarà quello di ribadire la centralità di questo legame in un lavoro comune che punti alla crescita degli uni e degli altri e alla loro collaborazione all’interno di un Ateneo che sia accogliente e solidale, dotato di infrastrutture moderne, di spazi di studio e di ricerca adeguati, in grado di erogare servizi che rendano la vita universitaria più ricca e inclusiva per ricercatori, studenti e lavoratori.
L’esigenza di mantenere elevato il livello della ricerca prodotta nella nostra Università richiede a mio avviso una politica di reclutamento sapiente e armonica, guidata inderogabilmente dalla qualità delle candidature, e insieme dal sostegno alle progressioni di carriera a tutti i livelli. Questo sforzo però deve procedere parallelamente a un impegno convinto e unitario contro tutte le forme di precarizzazione del lavoro di ricerca. Una percentuale ancora troppo alta dell’attività accademica oggi si regge su lavoratori e lavoratrici senza tutele e dal futuro troppo incerto. L’Università ha l’obbligo di fare tutto quanto è possibile per promuovere la valorizzazione dei meritevoli.
Sul terreno della didattica, intendo affermare con convinzione il valore insostituibile della formazione in presenza: essa garantisce la ricchezza del confronto diretto, la costruzione di relazioni spontanee tra studenti e docenti, la possibilità di vivere una comunità accademica fatta di dialogo, esperienze condivise e crescita personale oltre che culturale. Allo stesso tempo, l’esperienza della didattica a distanza ha mostrato la sua utilità come strumento complementare: ha ampliato l’accesso al sapere, offerto flessibilità, favorito la partecipazione di chi ha difficoltà logistiche o temporanee, permesso di mantenere un legame formativo anche in condizioni straordinarie. Il futuro della Federico II deve quindi fondarsi su un modello che tenga saldo il valore insostituibile della presenza, integrandolo con le potenzialità tecnologiche della didattica a distanza, così da costruire un’università più moderna, accessibile e inclusiva.
Sappiamo bene che la complessa macchina di cui stiamo parlando funziona ogni giorno grazie al contributo del comparto tecnico-amministrativo, che assicura con competenza e professionalità il corretto svolgimento di tutte le procedure che riguardano la vita accademica, dalle iscrizioni agli accordi internazionali, dai concorsi alle strutture di sostegno alla didattica e alla ricerca, dalla manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature dei laboratori all’assicurazione di procedure corrette sul piano della sicurezza e della qualità. Si tratta di un comparto che ha bisogno di riconoscimenti da parte di tutti e alle cui esigenze e alla cui crescita, attraverso processi di aggiornamento e formazione, credo occorra dedicare molta cura e attenzione, anche in vista di un potenziamento dei suoi assetti, di una semplificazione (entro i corretti perimetri normativi) dei procedimenti e di una cooperazione sempre più strutturata e funzionante tra Uffici centrali di Ateneo e articolazioni tecnico-amministrative dipartimentali e di Scuola.
Da ultima, ma non per ultima, la cosiddetta “terza missione”. La comunità federiciana non è solo dentro l’Università, ma anche fuori. Credo che uno dei punti di forza della Federico II risieda nel rapporto che da sempre intrattiene con il tessuto urbano, economico-produttivo e sociale in cui insiste. Ritengo pertanto necessario consolidare ulteriormente il legame con la città e con le istituzioni del suo territorio, immaginando la Federico II come polo multiculturale di portata euro-mediterranea, aperto al dialogo tra culture e saperi, capace di attrarre studenti e ricercatori da tutto il mondo e di offrire contributi scientifici e formativi riconosciuti a livello internazionale entrando in connessione con il proprio ambiente.
Il programma che proporrò non sarà un elenco di promesse, ma un patto di fiducia reciproca con la comunità accademica. Intendo farlo nascere dall’ascolto, dall’incontro e dal confronto che chiederò di avere nei prossimi mesi, dalle esigenze reali di chi ogni giorno lavora nella nostra Università: un programma che sappia tradurre in azioni concrete l’idea di un Ateneo pubblico, laico, pluralista, che tuteli e valorizzi le differenze, radicato nel suo territorio e aperto al mondo.
Sono certo che i prossimi mesi saranno una grande occasione per conoscerci meglio, confrontare idee e progetti, costruire insieme una visione condivisa del futuro della Federico II, che troverà solo allora espressione in un articolato programma e in una strutturata pianificazione degli interventi da promuovere.
Con l’auspicio di incontrarvi presto, vi ringrazio per l’attenzione e per la fiducia che vorrete accordarmi.
Un caro saluto a tutte e a tutti,
Andrea Mazzucchi