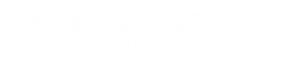“La Federico II ha un ruolo politico, economico e sociale rilevante nel Mezzogiorno (con 80 mila studenti, 4.080 docenti, 2.376 unità di personale tecnico amministrativo, dati 2023 MUR, e con un patrimonio netto nel 2024 di circa 528 milioni di euro) la sua azione deve pertanto essere ispirata da una gestione che ne garantisca l’autonomia, attraverso principi democratici, trasparenti e inclusivi.
Ma proprio l’autonomia universitaria, nel totale disinteresse a questi temi nella odierna campagna elettorale regionale, è oggi minacciata da progetti nazionali della maggioranza, che prevedono rappresentanti di nomina governativa e degli enti locali nei consigli di amministrazione degli atenei. La governance di ateneo, secondo il progetto, sarebbe subordinata a linee guida governative e alla figura apicale del rettore si aggiungerebbe la presenza di rappresentanti ministeriali e di enti locali. Insomma, un progetto che presenta forti dubbi di legittimità costituzionale, in ordine alla libertà di ricerca e di insegnamento e che andrebbe a ridimensionare l’autonomia e il ruolo delle componenti elettive. Il tutto amplificato da una imbarazzante proposta, sempre nel medesimo progetto governativo, di mandato rettorale di otto anni che potrebbe essere prorogato con un non meglio precisato voto plebiscitario. Come è stato detto, si passerebbe dall’uomo solo al comando all’uomo solo filo governativo (al comando) con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, in ordine all’insorgere di contaminazioni e relazioni pericolose.
In questo contesto, l’avvio della campagna elettorale per il nuovo rettore della Federico II non può prescindere dal porre con forza: da una parte la difesa dell’autonomia accademica dalla politica, dall’altra un netto ridimensionamento dei poteri del rettore, riconducendoli in binari democratici.
Per evitare il ripetersi del fenomeno delle autocandidature, abbiamo proposto (e sostenuto anche dal successivo intervento di Michelangelo Russo) di avviare, attraverso assemblee pubbliche di ateneo, un confronto aperto per la costruzione di programmi partecipati dal basso, oltre ogni tipo di personalismo.
In questo preoccupante scenario, occorre, dunque, far partire da subito queste pratiche, veri e propri anticorpi inclusivi a derive autoritarie, individuando alcuni temi sui quali concentrare i dibattiti assembleari e far crescere un pensiero critico di comunità.
La prima questione riguarda la riforma dello Statuto: va superata la dimensione monocratica della governance, favorita dalla Legge Gelmini e alimentata dai singoli statuti. É stata costruita una struttura decisionale centrata sulla figura apicale del rettore, senza alcun peso correttivo per un equilibrio dei poteri. Il consiglio di amministrazione è nominato sostanzialmente dal rettore, ancorchè sia previsto formalmente il consenso del Senato.
Il rettore dispone di enormi poteri, quasi assoluti, ciò determina un vistoso accentramento di ogni decisione, rendendo difficile la formazione di luoghi di confronto e l’emersione di una dialettica vera, genuinamente democratica e diffusa.
Tuttavia, in questi anni, molti atenei hanno modificato il loro statuto, ridimensionando i poteri del rettore con contrappesi opportuni, in particolare con l’introduzione dell’elezione, totale o parziale, piuttosto che la nomina rettorale dei membri del CDA (Bologna si è mossa recentemente in questa direzione, mentre in altri atenei il dibattito è aperto). Si potrebbe anche ragionare per prevedere, in uno statuto riformato, un voto di sfiducia al rettore, ad esempio da parte del Senato.
Si deve aprire, dunque, una stagione di partecipazione reale. I temi, a partire da quelli istituzionali, devono essere posti subito sul terreno di confronto. Ai buoni propositi vanno associate azioni efficaci e concrete. Nel caso del progetto governativo di vandalizzazione dell’autonomia universitaria, bisogna reagire con un documento da portare nelle sedi istituzionali, individuando tutti i profili di illegittimità dell’intervento legislativo. Rispetto alla necessaria riforma dello statuto della Federico II e del ridimensionamento del ruolo del rettore, occorre lavorare ad un articolato da presentare in assemblee pubbliche, coinvolgendo tutte le componenti della comunità federiciana, a partire da studenti e precari. Mai come in questo momento, la partecipazione ed i processi di responsabilizzazione potrebbero provare a fermare progetti lesivi dell’autonomia della ricerca e ricondurre la governance di ateneo a principi democratici.
Sono questi alcuni temi per noi centrali nel processo che porterà alla elezione del nuovo rettore e sui quali chiamiamo a pronunciarsi, su queste pagine e in assemblee pubbliche, non solo i candidati che aspirano a guidare per i prossimi anni l’Ateneo, ma chiunque voglia contribuire a rafforzare questo processo democratico.”
Alberto Lucarelli, Rosario Patalano