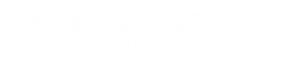Epidemiologia sociale, algoritmi e big data. Una disciplina affatto nuova, che tuttavia è tornata prepotentemente in auge con la pandemia da Covid-19 e il conseguente impatto sociale. Il corso prenderà il via l’8 marzo ed è rivolto agli studenti delle Magistrali di Sociologia digitale e Analisi del web, Innovazione sociale, Comunicazione pubblica, sociale e politica che potranno inserirlo come insegnamento a scelta (6 crediti) nel piano di studi. Dietro la cattedra, il prof. Michele Mezza, accolto dalla Federico II nel 2015 dopo una lunga carriera giornalistica che, tra le altre cose, l’ha visto inviato per il Giornale Radio della Rai in scenari come l’ex Jugoslavia e l’ex Urss. “L’idea è quella di sfruttare le onde di realtà che si sono già affermate in altri contesti come Stati Uniti e America Latina – racconta il docente – cioè assumere la malattia come fenomeno sociale, come un motore di processi di trasformazioni sociali da analizzare e da combinare con il contesto più generale. In particolare, ed è questa la vera azione del corso, assumendo come linguaggio e valore il fenomeno del big data e la capacità di raccolta e di elaborazione digitale che è venuta fuori”. Gran parte delle lezioni, inoltre, vedrà la partecipazione di esperti di settori specifici. Dal prof. Andrea Crisanti, docente di Microbiologia a Padova, che ha offerto un contributo al libro di Mezza “Il contagio dell’algoritmo” e ha invece pienamente collaborato a “Caccia al virus” (entrambi testi d’esame assieme alla lettura consigliata “Immunità comune” del filosofo Roberto Esposito); al prof. Pietro Nunziante del Dipartimento di Architettura, passando per il dott. Alfredo Budillon dell’Ospedale Pascale di Napoli.
La prima pietra, quella dalla quale le lezioni partiranno, è un elemento comunicativo che ha contraddistinto, finora, il rapporto con la malattia di questi tempi: la pandemia, di fatto, è stata raccontata innanzitutto da statistici, da fisici, prima che da virologi e medici. La conseguenza ineludibile ha a che fare con la rete, perché “la pandemia ha per struttura, tassonomia, fisionomia e dinamica un’assoluta sovrapposizione con il network”. Uno dei fari guida, per evitare le onde di un mare pieno di insidie, è il premio Nobel Parisi. “Analizzeremo in sovrapposizione la dinamica del mondo delle particelle sia virtuali che reali. Costateremo come il mondo delle particelle abbia fornito elementi per misurare e prevenire in alcuni casi il contagio. Questo ha chiaramente un impatto sul territorio, del quale potremo comprendere i processi di riorganizzazione che toccano la formazione, il lavoro, le relazioni sociali. Fattori che, è inevitabile, si adeguano e si intrecciano con i processi epidemiologici”. Chi seguirà le lezioni non resterà lì, fermo ad ascoltare passivamente. Poste le basi teoriche assieme agli ospiti di turno – “con Crisanti analizzeremo la capacità che ha avuto il sistema scientifico di prevenire, con Budillon come cambia il sistema sanitario alla luce di questa endemicizzazione del virus, con Nunziante invece vedremo come il territorio si riorganizza in struttura residenziale e produttiva” – due gruppi di lavoro si concentreranno sullo studio di due quartieri della città. Un laboratorio dove verificare effettivamente tutti i percorsi intrecciati durante il corso.
Il rapporto tra autore e utente
L’intervista a Mezza, però, al di là dell’epidemiologia e della stretta attualità legata al Covid, offre un’occasione molto ghiotta per comprendere come e quanto sia cambiata la comunicazione dagli albori della sua carriera giornalistica ad oggi. Nessun social network, ‘solo’ radio, televisioni e giornali. Un’informazione cadenzata quotidianamente da orari prestabili. All’opposto, oggi, un mare magnum di micronotizie invade i secondi e minuti dell’utente, che può fare estrema fatica a districarsi nel costante terremoto delle news. Mezza offre il punto di vista dello studioso. Di colui che è stato parte del meccanismo comunicativo e per questo ne conosce i meandri, studiati e approfonditi in diversi libri. “L’elemento di assoluta discontinuità tra il mio scenario e il giornalismo attuale non sono solo i social, ma la diversa dinamica nel rapporto tra informatore e informato – spiega – per molto tempo c’è stata una gerarchia unidirezionale per cui la notizia scorreva dall’uno all’altro e basta. Oggi, invece, questa relazione è diventata una conversazione largamente partecipativa. Ogni articolo, ogni servizio, è solo l’inizio di un processo in cui mettono mani autori e utenti. È un elemento di assoluta civiltà e soprattutto è irreversibile, bisogna prenderne atto. Tuttavia, siamo ancora ai primi passi di questa nuova forma civile in cui ogni legame culturale prevede sempre un livello di inevitabile collaborazione tra autore e utente. L’abbiamo visto con la pandemia, seppur con accenti di caos e ingovernabilità. I ruoli di pazienti, utenti, dell’opinione pubblica sono stati molto più presenti e dialettici che in altre circostanze. In passato l’autoritarismo del sistema scientifico e di informazione non era discutibile, ora abbiamo un meccanismo con il quale bisogna persuadere, convincere, raccontare dettagliatamente ogni passaggio”. In questo contesto, le fake news perdono consistenza. Non tanto perché non abbiano effetti su chi riceve l’informazione, ma “è un fenomeno d’ambiente, abbiamo esempi di notizie false diffuse pure in passato, da sistemi di informazione tradizionali. Io penso che sia sì un fenomeno degenerativo, ma del tutto momentaneo e contingente, che ci accompagna in una nuova fase dell’interscambio culturale”. Il cerchio si chiude tornando all’epidemiologia, al rapporto tra comunicazione, ricerca e scienza. “Abbiamo potuto vedere con chiarezza come la dinamica e la genetica dell’informazione, anche scientifica, si autorappresenta. I microbiologi che sono diventati di fatto delle star, al di là dell’elemento di costume, ci dice che la comunicazione è un elemento costitutivo della ricerca, ma lo era già con Galileo a ben vedere. Il punto è precisamente questo: costruire la comunicazione in base a chi si ha davanti, assurgendo all’obbligo però di dar conto di ciò che si dice”.
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli su www.ateneapoli.it