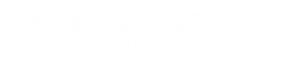Matematica e fisica sono materie aride, noiose, slegate dalla vita, non congeniali alle ragazze e per affrontare le quali bisogna essere ‘portati’, un po’ come accade per i musicisti: questi ed altri pregiudizi ci si è proposti di sfatare nell’incontro di “Come alla Corte di Federico II” del 15 marzo. La conferenza, tenuta dalla professoressa Elena Sassi ed intitolata “Educazione scientifica: una fisica più accessibile ed attraente” è stata un’occasione per riflettere sulle modalità più indicate per far appassionare i giovani alle discipline scientifiche. “La fisica e la matematica di solito sono considerate discipline difficili – afferma la prof.ssa Sassi – Per giunta, le idee ingenue che abbiamo sul mondo sono spesso in conflitto con quelle della fisica”. La prof.ssa ribadisce quanto il legame tra matematica e fisica sia indissolubile: “è difficile rendersi conto di come lo stesso modello matematico possa essere alla base di fenomeni molto diversi. Un esempio efficace può essere quello della caffettiera tradizionale, quella di De Filippo, per intenderci. Il modello che dimostra come fa l’acqua a farsi strada tra la polvere di caffè, spiega anche come si diffonde un incendio nella foresta o un’epidemia tra la popolazione”. La prima regola di un buon educatore è coinvolgere i giovani partendo dalle loro curiosità. “Nella scuola superiore, quando va bene, si arriva a studiare le scoperte del primo ‘900. Gli studenti, invece, si pongono domande legate a problemi dell’attualità che riguardano, ad esempio, la genetica clinica, l’informatica”, rileva la professoressa Sassi rammaricandosi, tra l’altro, che i ragazzi cresciuti con la tv siano abituati a fare zapping, davanti allo schermo così come nelle situazioni della vita. Anche per il prof. Nicola Cavallo, docente di Fisica presso l’Università della Basilicata, occorre insegnare il metodo, il ragionamento. “Il segreto è non soffermarsi eccessivamente sul particolare, non complicare, andare all’essenza delle cose”, interviene il prof. Bruno Preziosi. Cavallo mette, però, in guardia dai rischi della banalizzazione: “l’eccessiva semplificazione che non insegna alcunché, è pura informazione”. “Le teste degli studenti non sono recipienti da riempire! – esclama la prof.ssa Sassi criticando i metodi dell’insegnamento tradizionale – In un ambiente di apprendimento neocostruttivista si lavora insieme, si impara tra pari.” E ci si avvale anche dei vantaggi che le tecnologie possono offrire a chi desidera imparare: “Quando ho studiato gli atomi, io me li son dovuta immaginare; adesso si possono fotografare!”. La professoressa sostiene che spesso si insegna a risolvere problemi standard ricorrendo alle formule, ma si tralascia il legame tra teoria e pratica. La conoscenza così acquisita non è coerente né duratura. “Non serve il ricorrere ad una formula come ad una sorta di toccasana – afferma – Ognuno deve trovare il proprio modo per imparare. L’insegnante può dare degli stimoli ma l’apprendimento è un’avventura personale”.
“La mia ricetta è un po’ diversa da quella della professoressa Sassi – afferma il prof. Luigi Smaldone – Consiste nell’inserire nella lezione la vita di tutti i giorni”. “Un coltello, per esempio, può essere ideale per percepire la pressione e capire la funzione della punta affilata – afferma il professore che si dichiara un accanito sostenitore della cosiddetta “fisica del soufflé” – Con semplici esperimenti realizzati in cucina molte teorie possono essere “digerite” meglio”. Ma il professore per trasmettere il suo entusiasmo fa leva anche sulla sua naturale verve ed adopera a lezione una tecnica che si potrebbe definire istrionica. “Cerco di suscitare una risata ogni 5, 10 minuti – spiega – I tempi sono calcolati in base alla curva di attenzione. Dopo 10 minuti di spiegazione o si cambia argomento o si distraggono gli allievi per un attimo”. “Sono affascinato dal modo effervescente con cui il professor Smaldone conquista l’interesse degli studenti. Io sono molto più soporifero – afferma ironicamente il prof. Gianni Chiefari – Ogni tanto mi accorgo che i ragazzi sono stanchi, cerco di svegliarli ma sortisco meno effetto di lui”. “Contenuti e metodo sono inscindibili – sostiene la professoressa Sassi – Quando ci si accorge che lo studente che si ha davanti è annoiato, tocca mettersi in gioco emotivamente. Altrimenti sarebbero sufficienti i libri”.
Il dibattito ferve anche sulla necessità di invogliare i ragazzi ad iscriversi alle Facoltà scientifiche, magari migliorando la cooperazione tra Università e Scuola Superiore. Se il prof. Luciano De Menna afferma: “condanno l’atteggiamento snobistico che molti colleghi hanno nei confronti dell’attività di orientamento”, il prof. Guido Barone risponde: “io vado a caccia di studenti nelle scuole e cerco di adoperare strategie seduttive per attrarli”. “C’è un’aria di sufficienza nei confronti di chi si occupa di educazione scientifica – precisa la prof.ssa Sassi – A chi fa ricerca si chiede l’expertise. E’ indecente che per fare educazione basti invece aver seguito un corso”. L’educazione scientifica è fondamentale per formare i cittadini di domani “ma è difficile far accettare il fatto che la scienza non abbia sempre risposte pronte – rileva il Rettore Guido Trombetti – La scienza trova spiegazioni parziali di verità provvisorie. Gli scienziati dovrebbero impegnarsi per farlo capire anche fuori dalle aule”.
A difendere la categoria dei futuri insegnanti vi sono i molti studenti della Sicsi presenti in sala. “I professori ci insegnano con l’esempio a non annoiare”, dichiara Gabriella Crispino. “C’è da dire che siamo anche molto motivate, veniamo da una scuola ‘tosta’, siamo laureate in Matematica”, sostiene la collega Mariateresa Basile. “Professori giovani e preparati come il professor Italo Testa stimolano la voglia di fare e insegnano a ragionare in maniera critica”, aggiunge Caterina Muscariello. “A lezione cerco di far riferimento alle conoscenze pratiche degli studenti, a ciò che conoscono – riferisce con modestia il professor Testa, docente Sicsi, nonché ricercatore di Didattica della Fisica – Pongo domande senza fornire risposte certe. I ragazzi non sono abituati ad essere continuamente interpellati, ad ipotizzare soluzioni”. Non hanno acquisito un’esperienza didattica altrettanto positiva due studentesse di Medicina: “Molti professori si limitano a leggere il contenuto delle diapositive. Non interagiscono, sono poco portati per la didattica”, afferma Anna Franzone. “Accade soprattutto dopo i primi due anni – interviene Paola Iacotucci – In aula siamo troppi per poter porre domande”.
Manuela Pitterà
“La mia ricetta è un po’ diversa da quella della professoressa Sassi – afferma il prof. Luigi Smaldone – Consiste nell’inserire nella lezione la vita di tutti i giorni”. “Un coltello, per esempio, può essere ideale per percepire la pressione e capire la funzione della punta affilata – afferma il professore che si dichiara un accanito sostenitore della cosiddetta “fisica del soufflé” – Con semplici esperimenti realizzati in cucina molte teorie possono essere “digerite” meglio”. Ma il professore per trasmettere il suo entusiasmo fa leva anche sulla sua naturale verve ed adopera a lezione una tecnica che si potrebbe definire istrionica. “Cerco di suscitare una risata ogni 5, 10 minuti – spiega – I tempi sono calcolati in base alla curva di attenzione. Dopo 10 minuti di spiegazione o si cambia argomento o si distraggono gli allievi per un attimo”. “Sono affascinato dal modo effervescente con cui il professor Smaldone conquista l’interesse degli studenti. Io sono molto più soporifero – afferma ironicamente il prof. Gianni Chiefari – Ogni tanto mi accorgo che i ragazzi sono stanchi, cerco di svegliarli ma sortisco meno effetto di lui”. “Contenuti e metodo sono inscindibili – sostiene la professoressa Sassi – Quando ci si accorge che lo studente che si ha davanti è annoiato, tocca mettersi in gioco emotivamente. Altrimenti sarebbero sufficienti i libri”.
Il dibattito ferve anche sulla necessità di invogliare i ragazzi ad iscriversi alle Facoltà scientifiche, magari migliorando la cooperazione tra Università e Scuola Superiore. Se il prof. Luciano De Menna afferma: “condanno l’atteggiamento snobistico che molti colleghi hanno nei confronti dell’attività di orientamento”, il prof. Guido Barone risponde: “io vado a caccia di studenti nelle scuole e cerco di adoperare strategie seduttive per attrarli”. “C’è un’aria di sufficienza nei confronti di chi si occupa di educazione scientifica – precisa la prof.ssa Sassi – A chi fa ricerca si chiede l’expertise. E’ indecente che per fare educazione basti invece aver seguito un corso”. L’educazione scientifica è fondamentale per formare i cittadini di domani “ma è difficile far accettare il fatto che la scienza non abbia sempre risposte pronte – rileva il Rettore Guido Trombetti – La scienza trova spiegazioni parziali di verità provvisorie. Gli scienziati dovrebbero impegnarsi per farlo capire anche fuori dalle aule”.
A difendere la categoria dei futuri insegnanti vi sono i molti studenti della Sicsi presenti in sala. “I professori ci insegnano con l’esempio a non annoiare”, dichiara Gabriella Crispino. “C’è da dire che siamo anche molto motivate, veniamo da una scuola ‘tosta’, siamo laureate in Matematica”, sostiene la collega Mariateresa Basile. “Professori giovani e preparati come il professor Italo Testa stimolano la voglia di fare e insegnano a ragionare in maniera critica”, aggiunge Caterina Muscariello. “A lezione cerco di far riferimento alle conoscenze pratiche degli studenti, a ciò che conoscono – riferisce con modestia il professor Testa, docente Sicsi, nonché ricercatore di Didattica della Fisica – Pongo domande senza fornire risposte certe. I ragazzi non sono abituati ad essere continuamente interpellati, ad ipotizzare soluzioni”. Non hanno acquisito un’esperienza didattica altrettanto positiva due studentesse di Medicina: “Molti professori si limitano a leggere il contenuto delle diapositive. Non interagiscono, sono poco portati per la didattica”, afferma Anna Franzone. “Accade soprattutto dopo i primi due anni – interviene Paola Iacotucci – In aula siamo troppi per poter porre domande”.
Manuela Pitterà