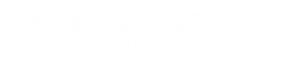Le matricole di Lettere Moderne, al primo semestre, dovranno cimentarsi con tre discipline cardine del percorso: Storia della Lingua Italiana, Letteratura Italiana I ed Elementi di Ecdotica, Stilistica e Analisi del testo letterario. Tre insegnamenti fondamentali per costruire una solida base linguistica, letteraria e filologica su cui poggeranno i successivi anni di studio. Alcuni docenti guidano alla scoperta dei contenuti e degli obiettivi di ciascun insegnamento, offrendo consigli utili agli studenti.
Letteratura italiana I
“Ho ripreso a tenere questo corso dopo quattro anni – racconta il prof. Antonio Perrone, titolare della cattedra di Letteratura Italiana I per il gruppo Q-Z – Lo avevo già svolto in passato, prima di dedicarmi alla Magistrale di Letteratura teatrale”.
Un ritorno che, nonostante il tempo trascorso e la “frattura epistemologica” della pandemia, conserva la stessa impostazione di fondo: “Alcuni studenti mi chiedono se servano manuali aggiuntivi di retorica, ma li rassicuro: il materiale fornito a lezione è più che sufficiente”. Il programma è comune a tutti i gruppi, una scelta condivisa per garantire omogeneità e continuità.
“In questo modo – spiega il docente – uno studente fuori corso potrà sostenere l’esame con un altro docente senza difficoltà. Inoltre, abbiamo rimodulato il programma per fornire gli elementi fondativi della storia letteraria italiana, ampliando allo stesso tempo il canone”. Tra le novità spicca l’inserimento di numerose poetesse del Tre, Quattro e Cinquecento: “Finalmente trovano spazio figure spesso trascurate nei manuali. È un passo avanti importante, non solo in ottica di genere, ma anche per restituire complessità ai fenomeni letterari”.
Un ampliamento che comporta inevitabilmente alcune scelte: “Togliamo qualcosa alla Commedia o al Canzoniere per inserire, ad esempio, sonetti di Gaspara Stampa. Meglio così. Dante e Petrarca hanno comunque corsi specifici o vengono ripresi alla Magistrale”. Sul piano didattico, Perrone osserva che molti studenti si aspettano un corso simile a quello affrontato al liceo: “In realtà, Letteratura Italiana è una disciplina più complessa. Alcuni la considerano più ‘accessibile’ rispetto a materie tecniche come l’Ecdotica, ma non è sempre così”.
Fondamentale, sottolinea, è comprendere che “ogni testo – poetico, narrativo o romanzesco – mantiene un legame profondo con i fattori storico-culturali della società che lo ha prodotto. Si può analizzare in senso ideologico o retorico, ma entrambi gli approcci funzionano solo se si ha ben chiaro il quadro storico di riferimento”.
Da qui la sua osservazione sull’organizzazione dei corsi: “Mi ha sorpreso scoprire che l’insegnamento di Storia Medievale sia collocato al secondo semestre. Avrei preferito che procedesse in parallelo al mio, perché storia e letteratura dovrebbero camminare insieme”.
Quest’anno, il corso assume un taglio particolare: “L’ho pensato come una storia dei media e dei fenomeni culturali. In 60 ore non si può affrontare tutto il manuale, perciò ho scelto di legare il percorso ai mezzi di rappresentazione – dal manoscritto alla stampa – così che gli studenti comprendano come la letteratura ci aiuti a interpretare il presente, anche in tempi difficili”.
Riguardo alla mole di testi, spesso percepita come impegnativa, il docente chiarisce: “È forse l’esame più corposo del triennio, ma se si adotta un metodo coerente – retorico o storico-culturale – si trova una chiave di lettura valida dal Cantico delle Creature di San Francesco fino alla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. In questa fase, la retorica domina e crea un codice culturale omogeneo, prima della frattura rappresentata dal Seicento”.
Sul piano pratico, Perrone si dice soddisfatto della gestione delle aule: “Rispetto ai miei tempi da studente, la situazione è migliorata: oggi tutti trovano posto, mentre io seguivo anche dai corridoi. Le lezioni si tengono nell’aula 26, nel Cortile delle Statue, e nell’aula Fadda. La divisione in quattro gruppi ha reso le classi più gestibili: in aula ho contato circa sessanta studenti, ma immagino che le presenze cresceranno nei prossimi giorni con l’avvio effettivo del calendario”.
Il docente nota infine una maggiore consapevolezza nelle nuove matricole: “Molti hanno un inquadramento professionale più chiaro rispetto al passato. Interrogandoli sul futuro, ho riscontrato idee precise, non sempre legate all’insegnamento, ma comunque ben definite”.
Storia della Lingua Italiana
Due moduli complementari per scoprire come si è formata e trasformata la lingua che parliamo ogni giorno. È così che il prof. Salvatore Iacolare, docente di Storia della Lingua Italiana per il gruppo D–K, presenta l’insegnamento: “Il corso si articola in due parti. Il primo modulo, di Storia della lingua, ha un taglio più storico e mira a far comprendere come l’italiano si sia evoluto dalle prime testimonianze scritte fino al secondo Novecento.
Il secondo modulo, di Linguistica italiana, approfondisce invece le strutture dell’italiano – lessico, morfologia, fonetica e sintassi – fornendo agli studenti gli strumenti tecnici per analizzare la lingua”. Percorsi distinti ma interconnessi: “Cerchiamo di farli procedere di pari passo, mostrando attraverso i documenti antichi come la lingua si trasformi nel tempo e nello spazio. Non ci limitiamo ai testi letterari canonici, ma osserviamo anche la variazione linguistica, come l’uso di forme locali o dialettali nei testi contemporanei”.
Tra gli esempi che più colpiscono gli studenti, racconta il docente, ci sono le lettere dei prigionieri della Prima guerra mondiale: “Rivelano un italiano ancora incerto, pieno di oscillazioni e ‘errori’. Ci aiutano a capire come molte forme, oggi considerate tipiche di persone poco scolarizzate o analfabete, fossero in realtà già diffuse all’epoca, quando l’apprendimento dell’italiano era ancora casuale e disomogeneo”.
Sul piano metodologico, il docente sottolinea la differenza tra le due direttrici: “La Linguistica è una disciplina più tecnica, tra le cosiddette ‘scienze morbide’ probabilmente la più dura. Richiede familiarità con un lessico specialistico e concetti complessi che non si assimilano subito”. Per questo motivo insiste sull’importanza di frequentare e interagire durante le lezioni: “Invito sempre gli studenti a non esitare a chiedere chiarimenti, anche durante la spiegazione. La cosa peggiore è rimandare i dubbi. Purtroppo ho notato che le matricole degli ultimi anni tendono a evitare il ricevimento, forse per timidezza o per mancanza di abitudine al confronto diretto”.
Nonostante la numerosità della cattedra – “superiamo le cento matricole per il gruppo D-K” – Iacolare cerca di introdurre momenti di attività pratica: “Quando affrontiamo, ad esempio, la trascrizione fonetica, formo piccoli gruppi che lavorano su esercizi mirati. Anche analizzare la presenza di tratti dialettali in testi di autori meridionali aiuta a comprendere meglio la variazione linguistica. Ho notato che quando gli studenti sono coinvolti attivamente, i concetti più tecnici risultano meno astratti e più accessibili”.
Il valore formativo del corso è però innegabile: “Molti arrivano dal liceo senza aver mai studiato la lingua in modo scientifico. Scoprono così un mondo nuovo, fatto di regole e strutture che spiegano come e perché parliamo in un certo modo. È un insegnamento che può davvero appassionare chi ama l’italiano, perché offre un modo diverso di guardarlo, più consapevole e curioso”.
Il docente mette in guardia anche contro una cattiva abitudine diffusa: “Molti si affidano alle dispense, ma spesso non si tratta di materiali ufficiali. Sono riassunti incompleti, venduti in cartoleria o scambiati tra studenti, che non riflettono i contenuti reali dell’esame. Studiare utilizzando queste scorciatoie significa arrivare impreparati.
È fondamentale lavorare sui testi indicati, integrando gli appunti delle lezioni e studiando con costanza, non solo a ridosso dell’esame”. Un consiglio valido, secondo Iacolare, “per tutte le discipline del primo anno”, ma particolarmente importante in questo insegnamento, che fornisce le basi per gli esami linguistici successivi: “Chi acquisisce familiarità con i concetti di fonetica, morfologia o sintassi troverà meno difficoltà in Linguistica generale al terzo anno”.
Elementi di Ecdotica e Stilistica
Elementi di Ecdotica, Stilistica e Analisi del testo letterario è un esame che spaventa e affascina allo stesso tempo. Fulcro della disciplina è il testo letterario, che la prof.ssa Anna Scafaro, docente dell’insegnamento per il gruppo A-C, invita ad affrontare come “un organismo vivo, da osservare, interrogare ed interpretare secondo diverse prospettive: filologica, metrica e sintattico-retorica”.
Per Scafaro l’obiettivo del corso è “fornire agli studenti non solo conoscenze teoriche, ma soprattutto strumenti di analisi e sensibilità critica. Voglio che imparino ad entrare dentro i testi, a riconoscerne le scelte linguistiche e stilistiche, a capire come forma e significato si intreccino nel costruire il senso dell’opera”.
Le lezioni, prevalentemente frontali, sono pensate come un dialogo continuo tra docente e discenti: “Non mi limito a spiegare passivamente: cerco di stimolare il dialogo e il confronto, invito gli studenti a riflettere sui problemi storico-filologici e sulla fisionomia metrico-stilistica dei componimenti che leggiamo ed analizziamo insieme. Bisogna rendere ciascuno parte attiva del processo di lettura e comprensione”.
Nonostante si svolga nelle ore pomeridiane, il corso ha registrato fin dai primi incontri un clima di entusiasmo e partecipazione. “Ammetto che dopo le prime lezioni temevo un calo di attenzione – confessa la docente – Invece continuo a trovare un’aula viva, curiosa, con studenti che pongono domande, intervengono, chiedono approfondimenti.
È un segnale molto incoraggiante: significa che il testo letterario, se proposto con passione, continua a suscitare interesse e desiderio di scoperta e che non viene visto come un esercizio meccanico e vuoto”.
Quanto alla modalità d’esame, permane la forma scritta e la preparazione richiederà uno studio accurato. “Non basta memorizzare nozioni o schemi, anche se per molti potrebbe essere la scelta più semplice – sottolinea Scafaro – Bisogna esercitarsi e mettere in pratica la teoria, partendo dai testi per sperimentare direttamente gli strumenti di analisi. Solo così si sviluppa una vera competenza critica, capace di andare oltre la superficie e cogliere la complessità di ciò che si legge”.
Giovanna Forino
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.16 – 2025 – Pagina 16-17