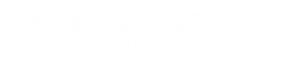“Ho sempre avuto un forte interesse per i fenomeni caotici e difficilmente incasellabili, quelli che si annidano nei margini e sviluppano atteggiamenti di rifiuto e di anticonformismo, insiti nello spirito degli esseri umani”.
Da questa curiosità nasce la scelta di Fara Florenzano, 29 anni, fresca laureata in Lettere Moderne (anno accademico 2024/2025), che ha dedicato la sua tesi di Linguistica Generale ad un argomento tanto affascinante quanto poco esplorato: il Polari, il gergo segreto utilizzato per decenni dalla comunità omosessuale della Gran Bretagna. Relatore dell’elaborato, il prof. Giovanni Abete.
“La scelta è nata dal desiderio di esplorare un linguaggio ai margini, complesso, stratificato, che ha rappresentato al tempo stesso una forma di protezione e un simbolo identitario”, racconta. La ricerca si è nutrita di letture specialistiche e di un accurato lavoro di consultazione.
Basandosi sulle ricerche del linguista Paul Baker, del lessicografo Eric Partridge, dello studioso Ian Hancock e di altri esperti, Fara ha ricostruito la storia di un codice linguistico che si è sviluppato nel corso dei secoli, raccogliendo influenze eterogenee e sorprendenti. Il Polari affonda le sue radici nel Thieves’ Cant, il linguaggio della classe criminale inglese in uso tra il XVI e il XIX secolo, che nel tempo si è intrecciato con le varietà linguistiche di subculture itineranti e marginali: uomini e donne di circo e di teatro, attori, ballerini, cantanti, organettisti italiani, burattinai, vagabondi, prostitute, marinai e mendicanti.
“Tutti gruppi che vivevano ai margini, accomunati da uno sguardo alternativo sulla società”, osserva la neolaureata. Accanto a queste contaminazioni sociali, anche Londra gioca un ruolo cruciale nello sviluppo del gergo. “Una metropoli affascinante e anonima, dove la libertà di costume offriva terreno fertile per le subculture”, spiega Fara. Tra le varietà linguistiche locali che hanno contribuito alla formazione del Polari, cita il back slang, il Cockney Rhyming slang e persino lo Yiddish, introdotto dagli immigrati ebrei e dal teatro popolare londinese.
Nel XX secolo, il gergo ingloba americanismi, soprattutto di natura sessuale, legati al contatto con i soldati alleati sbarcati in Inghilterra, e si arricchisce di termini legati al mondo della droga, riflesso della nuova subcultura urbana che stava emergendo.
Uno degli aspetti più intriganti messi in luce dalla tesi riguarda l’influenza italiana. “È possibile – racconta – che risalga alla lingua franca, considerando i contatti tra marinai, mendicanti e vagabondi nei porti, dove la prostituzione maschile era una pratica diffusa tra i parlanti Polari. Un’altra ipotesi è quella del contatto con artisti di strada italiani, organettisti e burattinai, i cosiddetti Punch and Judy men, ispirati alle maschere della commedia dell’arte”.
A testimoniare questo legame, anche alcuni termini di origine italiana, come mazarine per ‘mezzanino’ o voche per ‘cantante’. Nel 1969, il ballerino e coreografo Peter Gordeno pubblica persino un piccolo vocabolario del dancer’s language, con 19 lemmi noti e utilizzati nel Polari. “La questione dell’influenza italiana rimane aperta e affascinante”, commenta Fara.
Nel suo lavoro, la giovane laureata ha sottolineato come il Polari possa essere definito “il gergo degli outsiders per eccellenza”. Nato per eludere censura e moralismo, si è trasformato in un collante sociale e in uno strumento di affermazione identitaria. “Il parlante di Polari – spiega – si definisce bold queen, cioè una ‘regina audace’.
È colui che ostenta la propria omosessualità e abbraccia la femminilità, in un’epoca in cui questo era profondamente stigmatizzato. Parla di sé al femminile, si chiama mother, queen, lady, chiama i suoi pari sister e irride la polizia con nomignoli come Jennifer Justice o Betty Bracelets”.
Figure come queste, osserva Fara, anticipano la definizione moderna di gender non conforming: “Chi sfugge alle rigide codificazioni di genere. Gli uomini gay mascolini erano tollerati, ma non parlavano il Polari: si definivano husband, non queen. I parlanti di Polari invece rifiutavano il conformismo e trasformavano la femminilità, motivo di stigma, in una lente attraverso cui reinterpretare il mondo”.
Il lavoro di tesi si inserisce nel solco degli studi che, dagli anni Ottanta in poi, hanno rivalutato il gergo come ‘anti-lingua’, seguendo le riflessioni di Glauco Sanga, Ottavio Lurati e altri linguisti, che riconoscono in queste varietà un potente strumento di opposizione culturale e di costruzione identitaria.
“In conclusione – afferma Fara – ciò che più mi ha colpita è la complessa stratificazione linguistica che ha dato origine al Polari, in particolare l’influenza italiana, e la carica di audacia e ribellione che caratterizza i suoi parlanti. È una lingua che parla di libertà, di orgoglio e di resistenza culturale”.
Giovanna Forino
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.17 – 2025 – Pagina 21