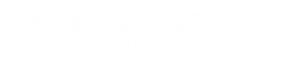Da diverso tempo, ormai, le notizie e il dibattito sui Campi Flegrei vertono in maniera quasi esclusiva sul bradisismo, sui terremoti, sui piani di evacuazione e sui danni riportati dalle case in seguito ai frequenti sismi, alcuni dei quali hanno raggiunto e superato la magnitudo 4.
Il Dipartimento di Architettura, con un gruppo di ricerca coordinato dal prof. Michelangelo Russo, sta portando avanti una riflessione più ampia, nel contesto di un laboratorio che si svolge in un luogo tanto bello quanto denso di significato: Villa Ferretti a Bacoli, bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato in uso all’Ateneo federiciano nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato circa tre anni fa dal Rettore Matteo Lorito e da Josi Della Ragione, il sindaco del Comune dell’area flegrea.
“A Villa Ferretti abbiamo incontrato – racconta il prof. Russo – esponenti istituzionali, imprenditori, il presidente del Parco dei Campi Flegrei ed altri per costruire strategie che possano diventare la base di strumenti di pianificazione”. Il docente definisce quest’attività “un laboratorio vivente, una tecnica di pianificazione. È nata nell’ambito di una ricerca del Pnrr e nel contesto di un partenariato esteso che si chiama Changes (Cultural Heritage Innovation for Next Gen Sustainable Society): una ricerca incentrata sui temi del patrimonio culturale che coinvolge anche il Dipartimento di Studi Umanistici ed altri Atenei, tra i quali Pisa, Torino, la Sapienza, Roma 3, Bari”.
È stato scelto il caso di studio dei Campi Flegrei “perché essi sono il paradigma di un paesaggio culturale che tiene dentro patrimonio, ambiente e biodiversità da gestire per costruire traiettorie di sviluppo”. La ricerca del Pnrr è iniziata nel 2023 e il laboratorio sui Campi Flegrei è partito da circa tre mesi. “Vi abbiamo fatto convergere – prosegue Russo – altre ricerche finanziate dal Pnrr nell’ambito dei cosiddetti bandi a cascata. Ne abbiano vinti due.
Lavoriamo per esempio con Inest, un Consorzio del nord est”. Cosa è emerso finora dal laboratorio? “C’è un forte bisogno e domanda di un modello di sviluppo sostenibile ed incentrato sulla mobilità su ferro efficiente, sulle auto, sulle bici e sulle navette elettriche, sul rafforzamento dei percorsi pedonali che si integrino con quelli di archeologia. Molti siti possono essere meglio conosciuti e visitati come nodi di una rete che possa valorizzare i Campi Flegrei come un grande parco archeologico all’aperto. Un processo che può giovarsi dell’incremento dell’ospitalità diffusa e che richiede anche una pianificazione per il recupero di aree industriali dismesse, per esempio la Sofer.
L’obiettivo del laboratorio è di delineare un progetto che possa diventare utilizzabile dalle istituzioni locali e dai Comuni di quel territorio. La nostra può diventare una ricerca applicata e trasferibile”. Sullo sfondo, ma ineludibile anche per il laboratorio del Diarc, la questione della crisi bradisismica: “La rete di mobilità sostenibile diventa anche un anello della catena necessaria alla messa in sicurezza dei territori.
Qualunque progettazione per i Campi Flegrei deve fare i conti con le necessità e con le esigenze legate alla gestione del rischio vulcanico e del rischio sismico. In questa prospettiva l’idea che sta emergendo è che reti infrastrutturali e punti di riunione possano essere utilizzati, qualora non ci sia l’emergenza, come luoghi di socialità, piazze e parchi pubblici. Possano in sostanza avere una duplice valenza”.
Fa.Ge.
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n. 13-14 – 2025 – Pagina 22