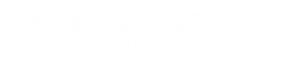Raccontare i trent’anni seguiti al secondo dopoguerra attraverso la canzone d’autore, “l’unica arte davvero patrimonio di tutti”, che “ha contribuito a cambiare il nostro modo di provare emozioni”. L’idea è della prof.ssa Barbara Della Salda, coordinatrice del Master in Radiofonia dal 2013, che su questa base ha scritto il libro ‘La canzone d’autore in Italia. Parte I: anni ’50, ’60, ’70’ e ha impiantato un ciclo di seminari dal titolo ‘Trent’anni della nostra storia raccontati con le canzoni’, per un totale di dieci incontri tra marzo e aprile aperti a 50 studenti di svariati Corsi afferenti al Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione.
“Parlando con i ragazzi – racconta ad Ateneapoli – mi sono resa conto che si conosce poco la storia dal secondo dopoguerra in poi, come se si fosse fermata al conflitto mondiale. Di conseguenza si dà un po’ per scontato che le cose, allora, fossero come oggi, in realtà sono molto diverse. In generale, gli ultimi cinquant’anni del secolo passato sono stati davvero fondamentali per l’evoluzione non solo del nostro modo di vivere ma anche del modo di pensare, sentire”.
Da qui la scelta di utilizzare la lente d’ingrandimento della canzone d’autore, nel suo essere patrimonio popolare, perché “la memoria, come base sulla quale costruire il futuro, non è importante solo per coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica e della comunicazione”. A partire dagli anni ’50, periodo in cui “si cominciava appena appena a parlare l’italiano, sono state la radio e la canzone ad insegnarcelo, prima si comunicava in dialetto. Racconterò come si viveva e cosa si ascoltava, ovvero una canzone era ancora in gran parte legata al melodramma, si utilizzavano rime baciate, frasi auliche, un italiano che era quello letterario dell’Ottocento”.
La virata verso una realtà più popolare, con i cantautori: “la svolta è stata avviata da Nanni Ricordi, un discografico illuminato che aveva lavorato a lungo all’estero. Si chiese perché la canzone italiana fosse così indietro rispetto al cinema con i neorealisti, alla poesia con ermetici e simbolisti: prese una serie di ragazzi della cosiddetta scuola di Genova – non avevano una formazione vera e propria, erano spontanei – e fece raccontare loro quello che sentivano, così come facevano in Francia gli esistenzialisti”. Gente come Gino Paoli, Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci: “ragazzi che raccontavano cosa provavano e sentivano i giovani”.
A definire meglio i riferimenti alla musica, la docente farà spazio anche a introduzioni sostanziali di carattere storico per raccontare il quotidiano: “negli anni ’50 c’era un bagno ogni sei appartamenti e si mangiava una sola volta al giorno; negli anni ’60 invece il boom economico aprì la strada verso la modernità. Negli anni ’70, invece, la virata fu politica, con i ragazzi che iniziavano ad avere un peso storico, e la musica dava voce e modo di esprimersi; maturarono come generazione a sé stante, capace di poter prendere posizione contro lo status quo. In quel contesto emersero le radio private come loro media”.
Claudio Tranchino
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n. 2 – 2025 – Pagina 34