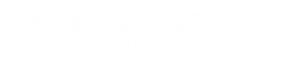Un nuovo capitolo nella formazione umanistica con l’avvio dei seminari di ‘narratologia’. Un percorso che nasce dal desiderio di ripensare il modo in cui si insegna a raccontare. “Non è banale un insegnamento di narratologia. Di solito si insegna la letteratura, la teoria letteraria o la critica letteraria.
Qui, invece, si studia la narrazione in tutte le sue forme: letteraria, filmica, grafica, visiva. È un approccio semiotico che permette di leggere qualsiasi testo, non solo un romanzo”, spiega la prof.ssa Paola Villani, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, coordinatrice del ciclo di incontri nell’ambito della Laurea Magistrale in Digital Humanities – Materie Letterarie. Ed è proprio da questa apertura che prende forma il calendario degli incontri, che intreccia testo e immagine, mente e parola, scienza e racconto.
Il progetto, racconta la prof.ssa Villani, affonda le sue radici nel congresso nazionale di Letteratura moderna e contemporanea svoltosi lo scorso maggio. “È lì che abbiamo deciso di costruire un calendario che facesse dialogare le diverse anime della narratologia italiana. È stato un lavoro faticoso, ma entusiasmante: volevamo portare ai nostri studenti la ricchezza dei diversi approcci”.
Un’anteprima si è già tenuta il 15 ottobre con Fabio Pierangeli (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) che ha aperto il dibattito con un intervento su maestri e scolari nell’Italia postunitaria, Elogio di Nelli e di Isabella. L’inizio di un percorso che proseguirà anche online, per coinvolgere studiosi impegnati in Italia e all’estero.
“Il punto di partenza però è il professore Stefano Calabrese, che da noi insegna Neuro Humanities – sottolinea la prof.ssa Villani – Da lì abbiamo sviluppato un’apertura cauta, ma convinta, al dialogo tra scienze umane e le hard science. Presentiamo approcci diversi, anche contraddittori: la forza dei luoghi accademici sta proprio nel confronto, anche con chi non è d’accordo”.
E il dialogo continuerà anche nei seminari successivi. Dietro la varietà degli argomenti c’è una direzione chiara: fornire agli studenti una grammatica universale del racconto. “Vogliamo che imparino a leggere l’architettura delle narrazioni in tutte le loro forme. Non solo testi letterari, ma serie TV, campagne pubblicitarie, contenuti digitali. Questo li renderà lettori più consapevoli e produttori migliori di narrazioni. Del resto, formiamo anche content manager: persone che dovranno saper scrivere e interpretare storie attraverso i linguaggi del web e dei media”.
I seminari si giovano di un metodo dinamico che alterna lezione teorica e pratica laboratoriale. “Dopo ogni incontro gli studenti lavorano sui testi – libri, film, immagini o post digitali – per sperimentare diverse morfologie narrative. Alla fine del percorso produrranno narrazioni originali che speriamo di trasformare in podcast. È questo lo spirito delle Digital Humanities: conoscere i linguaggi, ma anche i media che li trasmettono”.
E gli studenti accolgono la sfida con curiosità: futuri insegnanti 5.0 e umanisti digitali che, come li descrive la prof.ssa Villani, “vogliono raccontare in modo nuovo la letteratura e la cultura”. E forse è proprio questa la chiave per capire il senso più profondo del ciclo di incontri.
“Mi viene in mente Michail Bachtin il quale diceva che il romanzo è polifonico, perché dà voce a più punti di vista. Ecco, questo percorso è come un romanzo: polifonico, fatto di personaggi e visioni diverse. Abbiamo costruito un romanzo sui romanzi”. Dunque, un’opera in continuo divenire, creata collettivamente, che conferma il potere della letteratura e della narrazione nel decifrare e reinventare la vita che ci circonda.
Lucia Esposito
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.18 – 2025 – Pagina 47