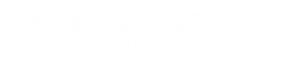Tante le iniziative promosse in Dipartimento. Un esempio: l’opportunità, per gli studenti della Triennale in Lettere Classiche (corsi di Paleografia 1 e 2) di visitare due tra le più importanti istituzioni bibliotecarie italiane – la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Vallicelliana. Relatore d’eccezione della giornata, che si è svolta il 5 giugno, il dott. Antonio Manfredi, scriptor latino della Vaticana, considerato uno dei maggiori paleografi a livello internazionale.
A guidare e accompagnare gli studenti, i professori Marco Cursi e Riccardo Montalto, titolari dei corsi, e il Coordinatore del Corso di Studi, prof. Giancarlo Abbamonte, il quale commenta: “Sono rimasto veramente colpito dalla consapevolezza che gli studenti della Triennale hanno già acquisito rispetto ai problemi paleografici. Alla loro età, io non avevo questa preparazione”.
La visita si è svolta nella storica Sala di Sisto V, un tempo sala di lettura della Vaticana, dove sono stati presentati e discussi alcuni manoscritti selezionati dai docenti. “Ha colpito molto gli studenti la predominanza di opere umanistiche rispetto a quelle sacre – prosegue Abbamonte – Un tratto che riflette la volontà dei papi umanisti che promossero la formazione di questo patrimonio”. La seconda parte della giornata si è svolta presso la Biblioteca Vallicelliana, capolavoro barocco progettato da Borromini e oggi gemellata con la Biblioteca dei Girolamini di Napoli, che sarà oggetto di una prossima visita prevista per ottobre.
“Entrare in questi luoghi, custodi della tradizione classica, ci ha permesso di toccare con mano i manoscritti e i documenti che finora avevamo soltanto studiato sui libri”, racconta Valeria Velleca che sottolinea come l’incontro con i testi antichi, mediato dalla guida dei docenti, abbia reso ancora più concreto e appassionante il percorso accademico. A condividere questa emozione è la collega Carmen Vicinanza, che parla di un vero e proprio viaggio nel tempo: “La Biblioteca Vaticana è un tempio della classicità, un luogo che sembrava irraggiungibile e che invece abbiamo potuto esplorare. Non ci sono parole per descriverla. Ammirare i soffitti affrescati e sfogliare il Cornu Copiae di Niccolò Perotti ci ha permesso di cogliere la magia della filologia”.
Una magia che si è ripetuta alla Vallicelliana, dove la storia dell’edificio si è intrecciata “con la possibilità di consultare manoscritti legati ai grandi nomi dell’Umanesimo e del Rinascimento e di far sentire la nostra voce come studiosi in divenire”. La forza della visita, però, non è stata soltanto l’accesso ai luoghi, ma soprattutto la possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante i corsi. Antonella Balbi lo evidenzia con entusiasmo: “Sfogliare i manoscritti che avevamo studiato a lezione ci ha permesso di trasformare la teoria in un laboratorio vivo. Abbiamo affrontato questioni codicologiche, osservato da vicino i materiali e quasi giocato a risolvere piccoli enigmi paleografici, sviluppando un senso critico che resterà con noi”.
L’esperienza, prosegue la studentessa, “ha reso più reale e tangibile la nostra passione per la filologia, mostrandoci come il lavoro sul campo sia un continuo dialogo con il passato”. Un dialogo che, per Annachiara Amato, ha trovato la sua massima espressione nell’incontro con i docenti, che hanno saputo guidare gli studenti e allo stesso tempo coinvolgerli nel dibattito: “Il dott. Manfredi ci ha mostrato ambienti normalmente chiusi al pubblico, come la Galleria delle Epigrafi, e ci ha accompagnati nell’analisi di manoscritti, alcuni dei quali oggetto di studio anche del prof. Abbamonte.
È stato emozionante vedere i professori confrontarsi direttamente sui codici, ragionare ad alta voce e condividere con noi le loro ipotesi; alla Vallicelliana, il prof. Montalto ci ha permesso di entrare davvero nella pratica filologica: abbiamo potuto formulare le nostre prime riflessioni e ipotesi, come in un piccolo seminario, e capire la differenza tra lo studio teorico e l’analisi diretta dei manoscritti. Un modo per abbattere anche una barriera tra discenti ed insegnanti”.
Così, tra suggestioni visive e scoperte filologiche, la giornata ha rappresentato un momento di autentica crescita, un ponte tra lo studio e la ricerca, capace di rafforzare la consapevolezza e la passione di chi, come queste giovani studiose, guarda alla filologia come a un mestiere e ad una vocazione. “Vedere i manoscritti dal vivo ci ha insegnato che la filologia non è solo sui libri – conclude Annachiara – Una possibilità unica che ha reso più forti e motivati chi, come me, ambisce a fare di questa pratica un vero e proprio lavoro”.
Scarica gratuitamente la nuova Guida Universitaria 2025 di Ateneapoli
Ateneapoli – n. 11-12 GUIDA UNIVERSITARIA – 2025 – Pagina 80