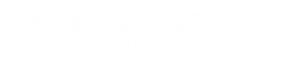Nel più grande museo del mondo, il Louvre, una banda di ladri si è introdotta all’apertura usando una camionetta fornita di montacarichi e arrivando al primo piano nella Galleria di Apollo, la più ricca di gioielli: corone con 1.300 diamanti incastonati, tiare di imperatrici cariche di smeraldi, oggetti dal valore inestimabile. Erano in quattro, due nel furgone, due su potenti scooter.
Dopo un’operazione cronometrata – 7 minuti in tutto – si sono dileguati, portando via otto gioielli e perdendone per strada soltanto uno, la preziosa corona dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, rimasta danneggiata nella movimentata fuga.
È accaduto una decina di giorni fa e la notizia ha naturalmente fatto il giro del mondo e ha sollevato dubbi sui sistemi di sicurezza del celeberrimo museo parigino. Ateneapoli ne ha parlato con la prof.ssa Gioconda Cafiero, docente di Museografia del Dipartimento di Architettura dell’Ateneo Federico II.
“Non esiste un museo a rischio zero, che sia completamente blindato rispetto alle incursioni dei ladri – chiarisce la prof.ssa Cafiero – I musei per loro stessa natura comunicano e diffondono notizie e informazioni sul patrimonio che è racchiuso al loro interno, mettono in mostra le foto delle opere sui cataloghi e sui siti internet e queste informazioni possono attirare l’attenzione anche di chi non abbia buone intenzioni.
Hanno una finalità di divulgazione e di esposizione che va nella direzione opposta rispetto a quella della sicurezza. La questione è naturalmente trovare un equilibrio tra le due esigenze diverse: quella di preservare le opere d’arte e quella di farle conoscere e consentire che il pubblico le veda”. Le moderne tecnologie certamente sono alleate importanti per potenziare all’interno dei musei le difese rispetto ai furti e agli atti vandalici, ma possono non essere sufficienti.
“Ci sono sistemi di controllo a distanza – ricorda la docente – che permettono di registrare il minimo movimento, esistono vetrate antisfondamento molto sofisticate, droni e quant’altro. Da un lato, però, sono tecnologie onerose e sicuramente non disponibili per la gran parte dei musei. Certamente per il Louvre sì, ma non per tanti altri o per le chiese che custodiscono opere d’arte. Dall’altro lato la necessità di garantire l’afflusso dei visitatori e di permettere loro di vivere l’esperienza della contemplazione dell’opera d’arte rende inevitabili alcuni margini di rischio.
Senza dimenticare che c’è sempre il fattore imprevisto: l’errore umano, il cattivo funzionamento di un dispositivo di sicurezza e quant’altro. Parrebbe il caso del furto clamoroso nel Louvre, prima del quale peraltro se ne sono verificati altri non meno clamorosi in diverse sedi museali del mondo, anche estremamente prestigiose”.
Cosa ha pensato la docente quando ha avuto notizia del furto dei gioielli di Napoleone? “Ho pensato al peggio per la natura specifica delle opere oggetto del furto. Le pietre preziose che compongono quei gioielli hanno un valore in sé e questo lascia temere che chi ne sia entrato in possesso smembrerà quei gioielli per ricavarne pezzi che possano essere venduti più facilmente.
Chi ruba un quadro certamente non lo fa a pezzi, infatti abbiamo celebri esempi di dipinti che sono stati ritrovati a distanza di anni. La stessa Gioconda di Leonardo circa un secolo fa fu oggetto di un furto e fu poi recuperata. Nel caso dei gioielli di Napoleone il rischio che la testimonianza storica vada perduta definitivamente è purtroppo elevato”.
“Il museo è un progetto corale”
Il fattore sicurezza è certamente parte della progettazione dei musei, alla quale concorrono professionalità e competenze eterogenee. Conferma la prof.ssa Cafiero: “Il museo è un progetto corale. Deve nascere dalla fusione di competenze diverse. Quelle degli storici dell’arte o degli studiosi di scienze che selezionano i documenti, ne pianificano un ordine ed una successione.
Quelle dei progettisti, dall’architetto allestitore che progetta anche il modo di presentare i documenti e la disposizione delle luci, quelle degli ingegneri che controllano anche aspetti di qualità ambientale decisivi ai fini della conservazione delle opere: l’umidità, la temperatura, la tenuta antisismica”.
Aggiunge: “È un progetto corale perché se solo una di queste dimensioni prevale sulle altre si rischia un cattivo esito. L’architetto che progetta gli spazi museali non può ignorare per protagonismo le questioni sollevate dagli storici dell’arte o dagli ingegneri. Questi ultimi non possono prevaricare sulla qualità dell’esperienza estetica e della funzione degli spazi. Un progetto di museo ben riuscito è il risultato di un sforzo di dialogo tra competenze”.
Cafiero ha un rammarico: “Purtroppo pochi architetti si dedicano alla progettazione dei musei e nei percorsi universitari non c’è grande spazio per lo studio e la progettazione degli spazi espositivi. È un peccato perché in Italia la museografia e l’allestimento hanno una storia importantissima.
La museografia del Novecento ha avuto contributi importantissimi da parte degli architetti in Italia. A tutto ciò non corrisponde l’adeguata rilevanza nei percorsi di studio universitari. Ci sono Master ed alcuni sono anche molto bene organizzati, ma la disciplina non ha molto spazio. Il che è paradossale se pensiamo all’abbondanza di siti artistici nel nostro Paese e al ruolo che la progettazione dei musei potrebbe avere nel futuro degli architetti”.
Fabrizio Geremicca
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.17 – 2025 – Pagina 3