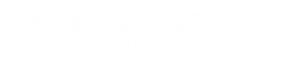Dopo quelli di Agnano, Fuorigrotta (via Claudio e piazzale Tecchio) e Monte Sant’Angelo, saranno installati sensori per monitorare lo scuotimento e la risposta delle strutture per effetto dei terremoti anche in altre sedi dell’Ateneo Federico II: a San Giovanni a Teduccio e nel centro storico, in particolare nell’edificio che affaccia sul Corso Umberto ed ospita la sede del rettorato. “Vorrei poi andare avanti – dice il professore Iunio Iervolino – con il Policlinico e con la sede federiciana di Scampia.
Non esistono molti Atenei al mondo con una tale rete di sensori per misurare le accelerazioni delle onde sismiche sui propri edifici. Probabilmente siamo gli unici”. Iervolino ha 49 anni ed insegna Dinamica delle Costruzioni e Ingegneria Sismica presso la IUSS – Scuola Superiore Universitaria di Pavia – e presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura federiciano, che coordina il progetto – se ne occupa anche il prof. Georgios Baltzopoulos – e che, insieme ai Dipartimenti di Ingegneria Civile, Fisica e Scienze della Terra forma la task force d’Ateneo che dal 2023, anno della sua istituzione, studia il rischio sismico derivante dal fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. Formano la squadra, oltre a Iervolino, i professori Aldo Zollo, Warner Marzocchi e Antonio Santo.
Le attività di studio dei fenomeni sismici per misurare e predisporre modelli di scuotimento prodotto dai terremoti ai Campi Flegrei verso Napoli e in particolare nei siti dei principali plessi dell’Ateneo sono condotte in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano e con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica. Il lavoro del gruppo interdisciplinare della Federico II ha anche prodotto studi che sono risultati utili per la gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione dell’Area Metropolitana di Napoli.
“I rilevatori ad Agnano, nelle due sedi di Fuorigrotta e a Monte Sant’Angelo – chiarisce il prof. Iervolino – sono stati installati a settembre. Si chiamano accelerometri e consentono di misurare quanto delle onde sismiche arriva fino alle sedi dell’Ateneo. Non solo delle onde sismiche legate al bradisismo, perché hanno rilevato, per esempio, gli effetti del terremoto di magnitudo 4 che c’è stato in Irpinia il 25 ottobre. Su alcuni edifici questi sensori sono stati posizionati solo a livello del suolo, su altri edifici anche in alto”.
I dati rilevati da settembre ad oggi in relazione alle sedi monitorate hanno evidenziato che ben poco dei sismi che ci sono stati nei Campi Flegrei nel periodo considerato è arrivato fino agli edifici federiciani. L’effetto di scuotimento è stato sostanzialmente trascurabile. “I terremoti dei Campi Flegrei – dice il prof. Iervolino – si attenuano molto rapidamente. Sono superficiali e per questo si sentono forti in prossimità dell’epicentro, ma il mezzo di propagazione delle onde sismiche è tale che esse si attenuano rapidamente.
Potrebbe dipendere dalla circostanza che la roccia è molto fessurata e che questa caratteristica determina una elevata dissipazione dell’energia. Abbiamo misurato un decadimento dell’ampiezza dello scuotimento a tre chilometri dall’epicentro del sisma pari al sessanta per cento”.
Appennino centro meridionale: “Lì le condizioni per sismi di magnitudo molto elevata ci sono”
Gli accelerometri già posizionati e quelli che saranno sistemati in futuro potranno anche indicare la necessità di attuare eventuali interventi per irrobustire le sedi universitarie ed eventualmente migliorarne la resistenza rispetto alle onde sismiche, sia che provengano dai Campi Flegrei, sia che siano state originate da alte sorgenti? “Naturalmente – risponde il docente – conoscere sempre più a fondo la risposta degli edifici ai terremoti è potenzialmente utile anche a progettare interventi tali da migliorare questa risposta.
Non è però questo lo scopo del progetto, che è essenzialmente di ricerca, e non credo che ci sia la necessità di intervenire sulle sedi universitarie, alla luce dei dati che abbiamo raccolto finora in relazione ai terremoti che si sono propagati dalla caldera di Campi Flegrei fino agli edifici monitorati”.
I componenti della task force coordinata dal prof. Iervolino, su richiesta del Sindaco Gaetano Manfredi e per il tramite del prof. Edoardo Cosenza, assessore della Giunta comunale ed ex preside della Facoltà di Ingegneria, hanno realizzato già diversi studi sui Campi Flegrei e sul bradisismo, alcuni dei quali sono stati pubblicati da prestigiose riviste scientifiche internazionali.
“È emerso che anche i sismi della caldera flegrea hanno origine dalle faglie. Ne abbiamo trovato una grande quantità. Rispetto ai terremoti che originano dalle aree non vulcaniche, cambia il meccanismo d’innesco. Nel caso dei Campi Flegrei è determinato forse dai gas o dal magma. In passato si riteneva che i terremoti delle aree vulcaniche fossero qualcosa di completamente diverso rispetto a tutti gli altri”. Questo aspetto delle faglie è importante perché, “se sappiamo che anche i terremoti dei Campi Flegrei originano sulle faglie e conosciamo l’estensione di esse, possiamo ipotizzare più o meno quale magnitudo possono generare.
Nei Campi Flegrei non ci aspettiamo terremoti molto più forti di quelli che abbiamo avuto fino ad oggi”. Le faglie dell’Appennino centro meridionale sono una storia diversa: “Lì potenzialmente le condizioni per sismi di magnitudo molto elevata ci sono”. Come del resto ha sperimentato tragicamente l’Irpinia il 23 novembre di 45 anni fa.
Fabrizio Geremicca
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.18 – 2025 – Pagina 14