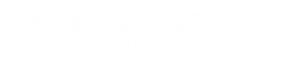Quando tradizione e innovazione si incontrano, nascono percorsi capaci di rivoluzionare il presente. È il caso di Pubblica Amministrazione e Cultura della prof.ssa Margherita Interlandi. Il successo del corso, ormai consolidato dopo tre anni di attivazione, è frutto di una visione audace: “Bisogna ringraziare sicuramente la prof.ssa Maria Ronza (Coordinatrice della Magistrale in Management del Patrimonio Culturale), che ha avuto l’intuizione di rinnovare il programma di questo insegnamento, a partire dalla sua stessa denominazione (in precedenza Diritto Amministrativo)”, spiega la prof.ssa Interlandi. Le lezioni, che prenderanno il via lunedì 24 febbraio, si apriranno con un inquadramento teorico del concetto di cultura, intesa non solo come insieme di beni materiali, ma anche “come valore identitario e democratico, profondamente radicato nei principi costituzionali”.
La Costituzione, infatti, non è soltanto una fonte del diritto, ma anche “l’espressione di una cultura fondata sulla centralità della persona e della sua libertà. È quindi fondamentale per gli studenti comprendere come questo concetto, per essere accettabile nel nostro ordinamento, debba rispettare questi principi”. Saranno poi chiariti gli approcci interattivi utilizzati, volti a privilegiare il confronto e il ragionamento: “Non mi limito a trasmettere nozioni in modo frontale, ma stimolo il dialogo in aula, ponendo domande e spingendo gli studenti a riflettere su temi centrali del diritto culturale”.
Spesso, si parte da quesiti semplici, come: “Perché la Pubblica Amministrazione si occupa di cultura? Quali sono i suoi strumenti di intervento? Da lì, costruiamo insieme un’osservazione più ampia e condivisa”.
Questa metodologia consente di adattare il linguaggio e gli strumenti didattici alla sensibilità degli studenti, evitando che la trasmissione del sapere avvenga in modo unidirezionale: “Noi docenti a volte diamo per scontato che la nostra visione coincida con quella dei ragazzi: non è così. Il loro modo di percepire la realtà è diverso e tocca a noi adeguarci a loro, non il contrario”. Accanto alle lezioni teoriche, la proposta di attività formative che offrono uno sguardo concreto sulla gestione del patrimonio culturale. Per fare un esempio: “Lo scorso anno, i miei studenti hanno avuto l’opportunità di visitare le Scuderie del Quirinale e di incontrare Mario De Simoni, ex presidente dell’Ales spa, società in-house del Ministero della Cultura. L’incontro ha permesso loro di approfondire le dinamiche della gestione museale, con un focus su esposizioni di rilevanza internazionale”.
E, grande novità di quest’anno, l’introduzione di un nuovo progetto: la realizzazione di uno o due podcast curati dagli studenti. “L’idea è di coinvolgerli direttamente nella creazione di contenuti, attraverso interviste a esperti del settore e direttori di musei. Stiamo valutando temi e luoghi di interesse, come Pompei o il Teatro San Carlo, in base alle disponibilità”. L’obiettivo è duplice: avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione e offrire loro un’esperienza pratica nella divulgazione del patrimonio culturale. Oltre a queste proposte, la docente incoraggia la partecipazione a seminari e incontri interdisciplinari, anche su tematiche non strettamente legate alla gestione culturale. “L’università deve riappropriarsi del suo ruolo di formazione della classe dirigente, fornendo strumenti per interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo. È importante che i discenti i non acquisiscano solo competenze tecniche, ma sviluppino una visione ampia e critica del mondo”.
Giovanna Fiorino
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n. 3 – 2025 – Pagina 27