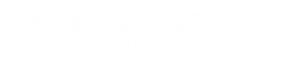Classe 1990, un percorso accademico costruito tra due nazioni, nel segno della passione per la trasmissione dei testi antichi e per la civiltà bizantina. È quello del prof. Luigi Orlandi, da ottobre docente di Filologia bizantina presso il Dipartimento di Studi Umanistici. “Sono federiciano – racconta – Ho iniziato il mio percorso di Laurea Triennale in Lettere Classiche qui, dal 2008 al 2011.
In quegli anni ho partecipato ad un Erasmus ad Amburgo: è stata la mia prima esperienza all’estero, il momento in cui ho cominciato ad interessarmi di critica testuale e di trasmissione manoscritta. Tornato in Italia, ho deciso di proseguire gli studi a L’Orientale, dove ho conseguito la Magistrale in Cultura e Filologia antica e moderna ed approfondito la bizantinistica, che poi è diventata il mio ambito di ricerca”.
Dopo la Laurea Magistrale, Orlandi ottiene una borsa di dottorato del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), l’ente tedesco per la promozione della ricerca internazionale: “Ho svolto il dottorato all’Università di Amburgo dal 2014 al 2017. Lì ho potuto lavorare in modo sistematico sui temi che mi appassionavano: la trasmissione dei classici a Bisanzio, la tradizione manoscritta, la paleografia greca. Tutti aspetti che restano oggi centrali nella mia attività scientifica”. Una formazione “italo-tedesca”, come la definisce lui stesso, che lo ha portato a collaborare con istituzioni di più Paesi.
“Ho preso parte regolarmente a conferenze e convegni anche in Francia e Spagna: l’importante per me era non perdere il contatto con il contesto accademico da cui provengo”. Dal 2017 fino all’autunno di quest’anno, il docente ha lavorato presso l’Accademia delle Scienze di Berlino, prendendo parte a diversi progetti di ricerca a tema filologico: “Iniziative di grande respiro, spesso legate alla medicina greca antica e alla trasmissione delle opere del Corpus Aristotelicum a Bisanzio: Galeno per la medicina, Aristotele per la filosofia. A partire dallo scorso gennaio, inoltre, ho ricoperto l’incarico di Arbeitsstellenleiter, cioè di coordinatore di unità di ricerca. È stata un’esperienza intensa e formativa”.
Poi il ritorno a Napoli, nell’Ateneo dove tutto era cominciato: la Federico II. “Avevo partecipato al concorso per la cattedra di Filologia bizantina e, intorno a Pasqua, ho saputo di essere risultato vincitore. Il mio servizio in Germania si è concluso il 14 ottobre, e dal giorno successivo ho preso servizio qui, alla Federico II. È una bella sensazione: ritrovare i luoghi e, in parte, le persone che mi hanno formato”. Una scelta che nasce anche da una riflessione più ampia sul mondo accademico.
“La Germania è stata per me il contesto ideale per la ricerca – prosegue Orlandi – A Berlino e ad Amburgo esiste una tradizione fortissima negli studi sulla trasmissione testuale, la paleografia e la circolazione dei classici. Lì hanno lavorato studiosi come Christian Brockmann e Dieter Harlfinger, figure che hanno segnato il campo”. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato: “Le iscrizioni ai corsi di latino e greco sono in calo, perché dai ginnasi arrivano sempre meno studenti interessati a proseguire questi studi. In certi casi ci si trova davanti classi di quattro o cinque persone”.
Una realtà che ha pesato sulla decisione di rientrare in Italia: “Qui, grazie alla tradizione del liceo classico, c’è ancora una base solida di studenti. Tornare significava non solo avvicinarmi a casa, ma insegnare in un contesto vitale, dove si può ancora trasmettere entusiasmo e formare nuove generazioni”.
Il suo corso di Filologia bizantina per la Triennale in Lettere Classiche è iniziato il 12 novembre. “Sono entrato in corsa – spiega – per questo motivo terrò un solo insegnamento in questo primo semestre, nel secondo ne offrirò tre, di cui almeno uno nel mio settore e gli altri più orientati ai temi della ricezione e della trasmissione dei testi”.
Il docente annuncia un’impostazione introduttiva per il suo insegnamento: “Sarà una sorta di ouverture sulla civiltà bizantina. Anche se la denominazione è ‘Filologia bizantina’, il corso offrirà lineamenti di storia e civiltà di una cultura millenaria che altrove viene trattata solo marginalmente. Presenterò i principali aspetti della cultura di Bisanzio, anche quelli materiali e legati alla produzione del libro. Bisanzio, infatti, è una civiltà del libro: è grazie al mondo bizantino che i classici dell’antichità sono stati trasmessi attraverso il Medioevo greco”.
Non mancherà l’approccio seminariale: “Pur mantenendo un taglio introduttivo, proporrò un’antologia di testi da leggere insieme. Vorrei che il corso fosse dinamico, con una partecipazione attiva degli studenti. Ho selezionato dodici o tredici autori rappresentativi di un intero millennio di storia, alternando nella prima parte i lineamenti di civiltà e nella seconda la lettura diretta dei testi”.
Agli studenti che sognano un percorso simile lascia un consiglio: “Direi di considerare il tempo degli studi come la più grande risorsa. È un’età privilegiata, e non bisogna mai chiedersi se si sta facendo troppo, ma semmai se si sta facendo abbastanza. Vivere esperienze fuori sede, frequentare, per conferenze e seminari, più di un Ateneo tra Triennale e Magistrale, partecipare a uno o più Erasmus: nel mio caso, studiare in quattro istituzioni diverse mi ha fatto bene. Non significa peregrinare, ma arricchirsi. E quando più istituzioni riconoscono il tuo lavoro, probabilmente stai andando nella direzione giusta”.
Giovanna Forino
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.18 – 2025 – Pagina 24-25