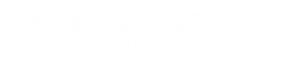L’otto ottobre nel Centro Congressi della sede federiciana a Monte Sant’Angelo si è svolta la ‘Giornata del naturalista’ promossa dal Corso di Laurea in Scienze Naturali: gli studenti hanno incontrato tra gli altri Salvatore Viglietti dell’Arpac; Pasquale Starace in rappresentanza del Comando Carabinieri Tutela Ambientale; Emanuele Biggi, naturalista che unisce ricerca e divulgazione e che è molto noto al pubblico per il ruolo che condivide con Sveva Sagramola di conduttore della trasmissione televisiva ‘Geo’.
Biggi è intervenuto in mattinata e per un paio d’ore ha raccontato la sua esperienza e risposto alle domande degli studenti. “Tutto iniziò – ha detto – con boboli e rospi. I boboli (così li chiamavo da bambino) non sono altro che porcellini di terra che mi hanno introdotto al mondo degli artropodi quando frequentavo l’asilo. In giardino davo calci alle siepi e ne cadevano tanti. Portavo anche a casa i rospi, che sono ancora la mia grande passione.
Sono animali che seguo ancora dal punto di vista scientifico e fotografico”. All’Università, ha ricordato poi, rispondendo ad una domanda della prof.ssa Olga Mangoni, Presidente del Corso di Laurea, “non ero tra quelli che correvano a fare il primo esame, non mi stressavo ma facevo il mio. C’erano esami che mi appassionavano ed altri meno. Tra questi Matematica al primo anno.
Stavo morendo ed ebbi 20. Facevo comunque tanta pratica anche autonomamente ed ero animato da grande curiosità su tutto. Fotografavo, allevavo animali in casa come le rane. Frequentai anche il dottorato dopo la laurea, che allora era quadriennale. Era una ricerca molto fisiologica, legata ad un ormone tiroideo, ma mi prendeva poco”.
Il verso della Rana di Vetro in Perù: “una emozione incredibile”
Ha poi ricordato: “Come naturalista io nasco erpetologo e forse lo capite se guardate il mio braccio. Ho tatuata la vipera delle sabbie del deserto del Namib. Ho sognato per tutta la vita di andare ai tropici a vedere animali, di scoprire la natura non solo intorno a casa e nel 2006, quando mi ero appena laureato, riuscii ad andare in Burkina Faso in una spedizione entomologica con amici francesi. Quella che veramente mi ha dato una marcia in più è stata la spedizione, nel 2008, nella foresta nebulosa andina, in Perù. Eravamo a 2500 metri di altitudine a metà strada tra la vetta andina e la foresta amazzonica.
Lì c’è una vita incredibile. Ero lì per documentarla e per raccontare anche quello che facevano i ricercatori, per esempio Alessandro Catenazzi, un professore italo-svizzero di origini peruviane. Una vita incredibile con migliaia di specie vegetali, dal più piccolo muschio fino alle felci, animali incredibili. Mentre ero lì con Catenazzi e poi negli anni successivi in quel luogo sono state scoperte diverse specie animali nuove. Per esempio una raganella. Io ero passato cinque minuti prima di lui e non l’avevo notata, Alessandro la vide.
Oppure nel 2016 una ranocchia che è stata ribattezzata metallara per l’aspetto molto particolare. In Perù ho provato l’emozione di rivedere la Rana di Vetro, il canto della quale non si ascoltava più da dieci anni. Si temeva fosse estinta. Quella notte udimmo il verso, ci infilammo in un torrente molto ripido insieme ad alcuni assonnatissimi studenti che erano con noi e scorgemmo un maschio. Una emozione incredibile”.
La divulgazione è l’altro aspetto della vita di Biggi, non meno importante e significativo rispetto alla ricerca e all’esplorazione sul campo. “È fondamentale non solo per condividere la bellezza, ma per mettere in luce i problemi che la minacciano. Le foto sotto questo aspetto svolgono un ruolo essenziale”.
“Le notti estive punteggiate dalle lucciole sono pura poesia”
Ne ha mostrate diverse durante la conferenza: un pesce tropicale che aveva scelto come tana una bottiglia di plastica, un macaco a rischio estinzione che in riva ad un fiume preferiva bere da una bottiglia in plastica abbandonata, evidentemente attratto anche dal contenuto zuccherino della bevanda che era lì dentro; un paguro che nel Borneo ha fatto la casa non in una conchiglia ma in un tappo di un contenitore di deodorante.
Ha proiettato foto delle testuggini in vendita al mercato per il consumo alimentare – “sempre praticato dagli indigeni, ma che se esteso a numeri superiori minaccia la specie” – e immagini di specie aliene che arrecano gravi danni all’ecosistema che colonizzano, come il gambero della Louisiana.
“Ci si può chiedere – ha interrogato gli studenti – cosa perdiamo dalla scomparsa delle specie. Vengono meno servizi ecosistemici, cose che giovano anche alla nostra sopravvivenza, come quelli della formica legionaria che caccia soprattutto erbivori e mantiene l’equilibrio necessario alla permanenza della foresta o come quelli delle formiche tessitrici che, tra l’altro, aiutano a tutelare le coltivazioni di mango da cavallette e bruchi delle quali si nutrono”.
Ha aggiunto: “La scomparsa di una specie per cause antropiche – le estinzioni ci sono sempre state, ma allarmano se sono repentine e avvengono in tempi brevi – è anche una perdita culturale e direi emotiva. Immaginate cosa sarebbero le nostre estati mediterranee senza le cicale. Io sono ligure e quando cominciano a cantare alla fine di maggio gioisco. Sono la musica della nostra estate. Oppure pensate alla bellezza e all’emozione che ci danno le lucciole.
Sono animali certamente utili perché si nutrono di chiocciole e lumache che possono danneggiare le coltivazioni, ma che per noi rappresentano molto di più. Le notti estive punteggiate dalle lucciole sono pura poesia, straordinaria emozione. Bellezza”. La perdita di una specie e di un ecosistema, ha proseguito il naturalista, significa anche il venir meno per l’uomo di utilizzare e sintetizzare composti che possono avere importanti funzioni terapeutiche e medicinali.
“In una specie di rana – ha raccontato – è stata scoperta una sostanza che è considerata un potentissimo antidolorifico, privo degli effetti collaterali della morfina. Uno scorpione possiede una clorotossina che può colpire le cellule tumorali”.
Nel caso della rana e dell’antidolorifico siamo andati molto vicini a perdere quel potente alleato contro il dolore, come ha ribadito Biggi rispondendo alla domanda di una studentessa: “I ricercatori che avevano effettuato la scoperta tornarono tempo dopo nella foresta per proseguire lo studio, ma non la trovarono più.
La foresta era stata distrutta per le esigenze di una multinazionale statunitense che produce mobili. Per fortuna furono individuate in altre zone rane di specie diverse che producevano una sostanza molto simile a quella già individuata”.
In tv “semplificare sì, ma senza banalizzare”
Biggi, su sollecitazione di alcune domande, ha naturalmente parlato anche della sua esperienza televisiva di conduttore di Geo. “L’obiettivo che ci poniamo in tv – ha spiegato agli studenti – è semplificare sì, ma senza banalizzare e mantenere il livello scientifico. In tv io sono l’ignorante, sono quello che stimola l’ospite, l’esperto sui vari argomenti. Cerco di capire come è di carattere, se più chiuso o se è abituato a parlare.
Il vostro Donato Giovannelli (docente federiciano che svolge ricerche in ambienti estremi ed è stato ospite di Geo, n.d.r.) se lo tocchi suona. Per altri non è così. Se poi viene un erpetologo mi esalto e devo tenermi a freno, perché tendo a parlare più io di lui”.
Nel corso della Giornata sono stati premiati i vincitori del concorso ‘Scatti della Natura’, al quale hanno partecipato diversi studenti. La prof.ssa Mangoni ha annunciato il varo di un Open Badge, una sorta di minicorso dedicato alla fotografia naturalistica aperto a iscritti di vari Corsi di Laurea al termine del quale si ottiene una certificazione di competenze firmata Federico II. Ha chiesto a Biggi la disponibilità a dare il suo contributo.
Fabrizio Geremicca
Scarica gratis il nuovo numero di Ateneapoli
Ateneapoli – n.16 – 2025 – Pagina 4-5